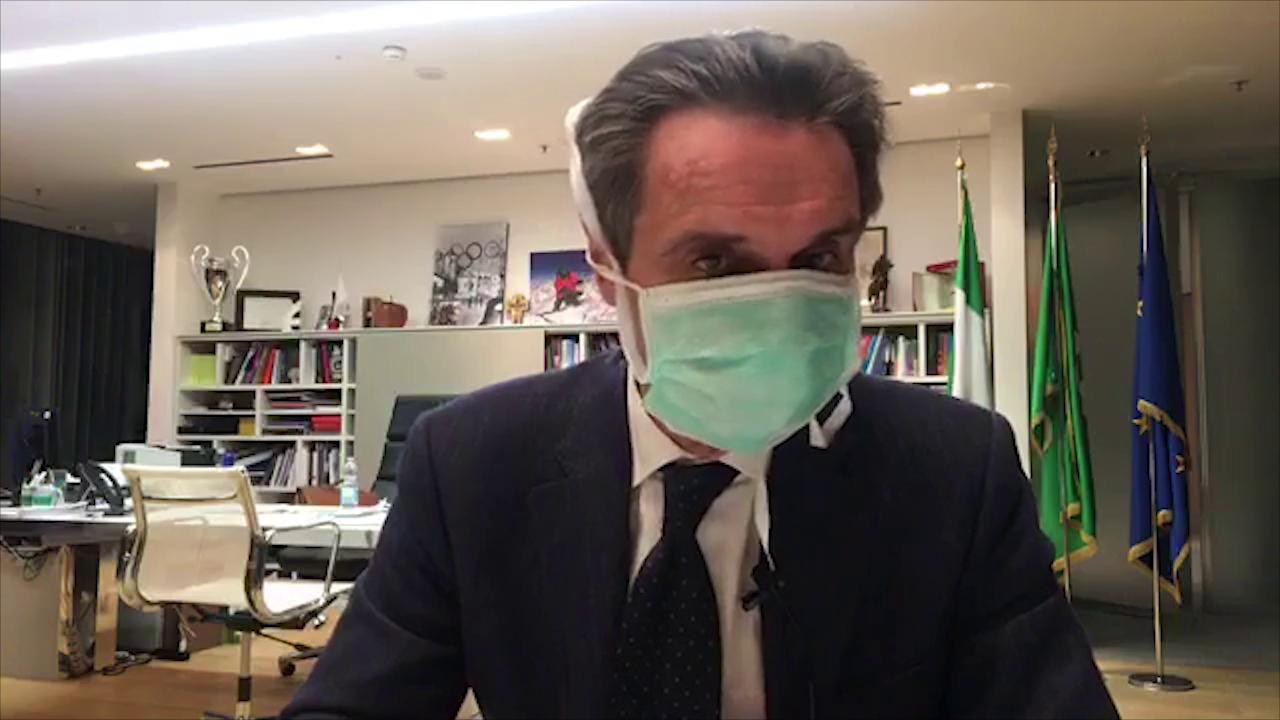La spinta a riaprire tutto o quasi dal 4 maggio, e anche prima, è fortissima. Da Confindustria ai governatori del Nord, da Salvini a Renzi, a Patuanelli, dai commercianti ai bagnini, ai gestori di bar e ristoranti. Tanto forte che il giornale degli industriali è arrivato ad ospitare un intervento nel quale è scritto, testualmente: “Non è la mortalità eccessiva a livello nazionale che giustifica il blocco prolungato dei diritti e della vita degli italiani”.
Il governo, in particolare con il premier Conte e il ministro Speranza, finora è apparso cauto. Più attento agli ammonimenti dei virologi e degli epidemiologi, e alla tutela della sanità pubblica. In Merket style, si potrebbe dire. Ma le divisioni nella maggioranza tra prudenti e temerari pesano.
Le pressioni sono enormi. E ci sono segnali, dalla sospensione della conferenza stampa quotidiana della Protezione civile alle notizie rassicuranti fatte circolare negli ultimi giorni sull’indice di contagiosità sceso sotto l’1% (calcolato però sui contagiati ufficiali che sono un decimo di quelli reali stimati, quindi vale quel che vale), che fanno pensare a grandi manovre in corso per accelerare la riapertura.
Né, d’altra parte, si può pensare di tenere ancora bloccato a lungo il Paese. E nemmeno di prorogare gli arresti domiciliari agli italiani anche dopo il 3 maggio. Né l’una né l’altra ipotesi reggerebbero.
Le conseguenze economico-sociali, già ora pesantissime, sarebbero devastanti. E lo stato di prostrazione dei cittadini, già molto provati da 40 giorni di isolamento, rischierebbe di fare più danni del virus. Inoltre, altri paesi in Europa, dove pure la pandemia è arrivata dopo, sono già pronti a ripartire. Restare indietro vorrebbe dire rischiare di non riuscire più a rialzarsi. Ma il rischio che le ragioni dell’economia prevalgano sulla salute, che i soldi contino di più della vita, è altissimo.
Nel panorama mondiale l’Italia è ancora tra gli Stati messi peggio per diffusione del contagio e mortalità. E la Lombardia, in particolare, ancora ieri aveva il 94% dei nuovi casi italiani. Con la metropoli milanese che ora è la nuova emergenza: 15.546 contagi tra città e provincia, 2.433 morti certificati per coronavirus, e 2.273 malati accertati nelle case di riposo sugli oltre 7.000 censiti a livello regionale. Le domande di fondo, a questo punto, sono tre. Ci possiamo fidare ci chi dice che il peggio è passato? Siamo pronti per ripartire? Cosa manca e cosa si dovrebbe fare per farlo in relativa sicurezza?
La risposta alla prima domanda, per quel che vedo io, è un no secco. La regione più industrializzata d’Italia non si è mai fermata. Tranne Codogno, non ha chiuso le aree focolaio. I casi nella bergamasca, della Val Seriana e di Alzano Lombardo sono clamorosi. La gran parte delle aziende ha continuato a produrre come prima. Centinaia di migliaia di lavoratori hanno continuato a prendere bus e metrò durante il lockdown. E non risulta, leggendo cronache e testimonianze, che le fabbriche, il lavoro, i trasporti siano stati messi in sicurezza. Per non parlare delle case di riposo e del clamoroso fallimento della medicina territoriale. Non è certo un caso se in Lombardia il virus ha proseguito e prosegue tuttora la sua corsa. Secondo il professor Galli dell’ospedale Sacco di Milano, una delle voci più credibili sul Covid, i contagiati reali in Lombardia si possono stimare sopra i seicentomila, contro i sessantamila ufficiali. Riaprire tutto in questa situazione sarebbe, a suo parere, un azzardo pericolosissimo.
Diverso è il discorso in Veneto e in Emilia-Romagna. Il Veneto ha gestito bene l’emergenza. Sotto la guida del centro di riferimento di microbiologia di Padova, il primo in Italia a cogliere i reali pericoli del virus, ha isolato il focolaio di Vo’, ha puntato fin dall’inizio a fare i tamponi ai sintomatici e ai loro contatti (per ogni caso di coronavirus scoperto, in Veneto si sono fatti 14,8 tamponi contro i 3,6 della Lombardia e i 5 dell’Emilia-Romagna. Nel mondo i paesi che ora stanno meglio ne hanno fatto 20 e più per ogni caso), ha lavorato più sul territorio che con gli ospedali, ed è riuscito a contenere piuttosto bene la diffusione della pandemia. In Emilia-Romagna la situazione è più a macchia di leopardo, con Piacenza e Parma che stanno uscendo a fatica dalla bufera lombarda che le ha investite, con l’incendio di Rimini e il focolaio di Medicina, con il resto della Romagna, Bologna e soprattutto Ferrara colpite molto meno, e Reggio e Modena a metà strada. Ma in generale la sanità emiliano-romagnola ha retto, le terapie intensive non sono andate in crisi, sono stati creati molti nuovi posti letto e reparti Covid. E anche se, all’inizio, non sono mancati errori e ritardi – soprattutto per le scarse protezioni del personale sanitario, i pochi tamponi e le poche diagnosi precoci sul territorio – oggi la situazione appare più sotto controllo e in costante miglioramento.
Riassumendo, se in Veneto e in Emilia-Romagna il peggio sembra effettivamente passato, altrettanto non si può dire della Lombardia. Mettendola in politica, di Zaia e Bonaccini forse un po’ ci si può fidare, di Fontana (e Salvini) proprio no. Ma nessuna delle tre regioni è pronta per ripartire. Intanto perché il contenimento del virus non è ancora sotto la linea di sicurezza, che ragionevolmente dovrebbe essere il calo dei contagiati e dei morti e non la loro minore crescita. Poi perché in questi 40 giorni di reclusione forzata il Covid19 ha continuato a circolare negli ambienti interfamigliari, nei condomini, nelle fabbriche aperte, nelle case di riposo e anche tra gli operatori sanitari. E chi usciva con i mezzi pubblici per andare al lavoro, o anche al supermercato, ha continuato a portarlo in giro. Il contrasto del virus nei territori, casa per casa, con diagnosi preventive, isolamento e cura domiciliare dei malati, mappatura dei loro contatti, è rimasto in gran parte nelle raccomandazioni degli esperti e negli annunci dei politici. Con il problema enorme degli asintomatici che non sono mai stati testati. Mentre la famosa App “Immuni” per tracciare i contatti dei malati ancora non c’è, così come un test epidemiologico nazionale. E si fa ancora fatica, dopo due mesi dall’esplosione della pandemia, a trovare mascherine e guanti. Per tutte queste ragioni, è molto probabile che quando si riaprirà il virus torni ad accendere nuovi focolai.
Cosa manca e cosa bisognerebbe fare per riaprire in relativa sicurezza lo aveva detto nei giorni scorsi il consulente del governo, Walter Ricciardi: tamponi a tutti i sospetti, App per monitorare i contatti coi positivi, messa in sicurezza delle aziende e dei trasporti, niente aperture affrettate nelle zone più a rischio, mobilità limitata. Ora si aspetta che il supermanager nominato da Conte, Vittorio Colao, traduca il tutto in un piano preciso. Siamo ancora nella fase della definizione della strategia e delle linee guida. Poi tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. E il fare è ancora indietro, molto indietro. Dice il professor Galli: “Non vorrei ritrovarmi nella situazione in cui si riapre tutto solo con mascherina, guanti e distanziamento. In queste due settimane bisogna poter agire su quelli che sono chiusi in casa con la malattia. Prima che ricomincino a uscire e a lavorare, servono accertamenti sui nuclei famigliare, capire chi è entrato in contatto con i malati, magari con degli asintomatici, perché non saperlo è un problema serio per la ripresa. E siccome non si possono fare i tamponi a tutti, bisogna anche dare la possibilità di sperimentare i così detti test rapidi, che pure hanno una serie di magagne. Infine serve uno schema per le aziende con l’indicazione precisa di quello che devono fare, dando anche a loro la possibilità di fare test rapidi”.
E proprio quella dei test sierologici è oggi una delle questioni centrali. Ce ne sono già molti in circolazione, quasi tutti promossi dai privati, non si sa quanto affidabili. Le aziende spingono per averli e per poter testare i loro dipendenti. In Lombardia è già partito il fai da te con test rapidi che si comprano a 100-150 euro l’uno. L’Emilia-Romagna frena, vuole il controllo pubblico sui test, ha ordinato direttamente 500mila kit. Ma è un lavoro lungo e i tempi sono stretti. Basta pensare che solo la metà degli operatori sanitari dell’Emilia-Romagna è stata finora sottoposta al test sierologico. E se è così nella sanità, pensate a come sarà nelle aziende. Ma oltre a questo servono anche altri interventi. Bisognerebbe prima di tutto investire sulla correttezza e responsabilità dei comportamenti individuali, abituare le persone a prepararsi alla fase due. Finora si sono viste più le azioni dei delatori e quelle repressive di polizia, carabinieri e vigili che le campagne comunicative mirate a sensibilizzare le persone ai comportamenti virtuosi nella nuova quotidianità che ci aspetta. Poi servono interventi concreti delle amministrazioni e delle aziende sui mezzi e le modalità del trasporto pubblico. Occorrono norme, strumenti e protezioni adeguati per fare in modo che il lavoro in fabbrica e in ufficio sia sicuro. C’è bisogno di regolamenti chiari e sensati per l’uso degli spazi pubblici, l’accesso ai mercati, ai parchi e alle spiagge, e quando si potrà ai negozi, ai bar e ristoranti. Un lavoro enorme che per ora si intravede soltanto, qua e là. E il 3 maggio è domani.
Argomenti: covid-19