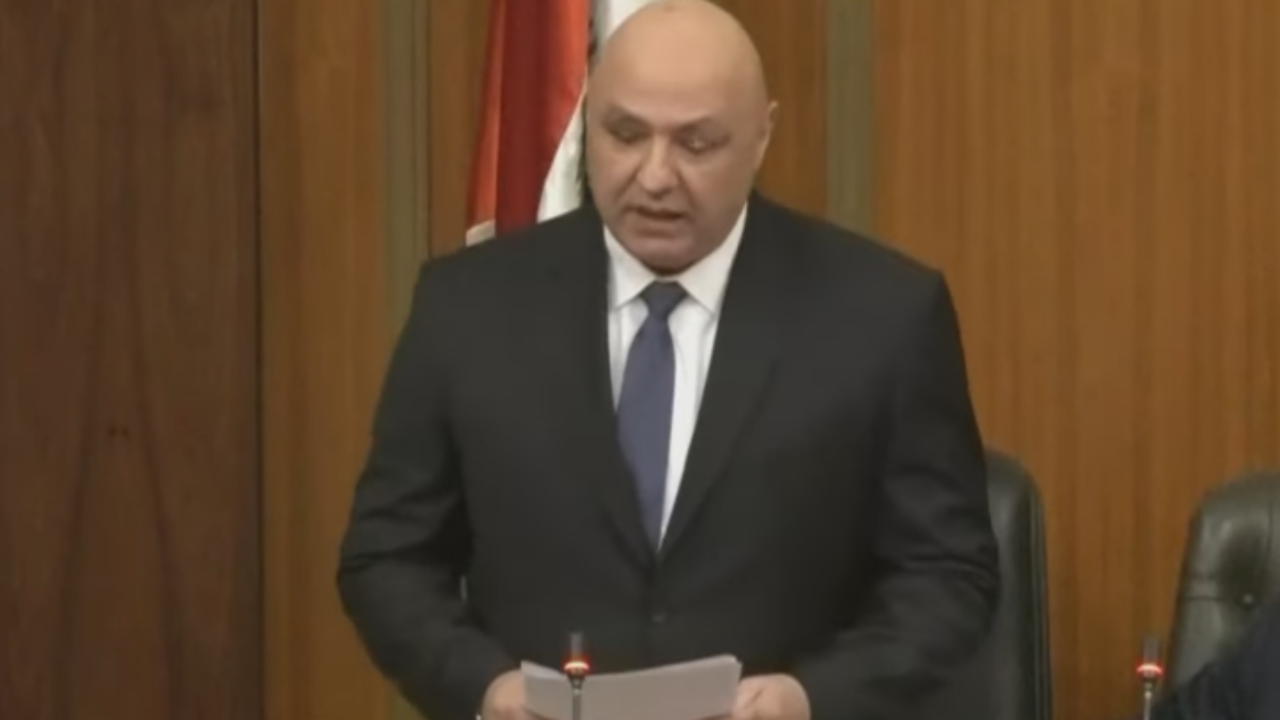Misuriamo la vita sugli anni che viviamo, forse sarebbe più saggio farlo sugli incontri che facciamo. Tra i più importanti per me c’è stato quello con Samir Frangieh, un grande intellettuale, arabo, maronita, libanese, tra le figura di maggior spicco in tutto il Levante arabo. Gli chiesi subito perché abitasse a Mar Elias, una strada molto nota in quello che chiamiamo il versante musulmano di Beirut e non nel versante cristiano della città. La risposta la ricordo quasi testualmente: “vivo qui da sempre, ci sono sempre tornato durante tutta la guerra civile, non mi sposto per tanti motivi, soprattutto perché non potrei cominciare la mia giornata, quando esco, senza scambiare due parole con Ali, il verduraio che ha la sua bottega qui sotto. Quando hanno ucciso Hariri, riferendosi a quelli di Hezbollah, sciiti come lui, mi ha detto: “io non li capisco, per uccidere un sunnita ce ne siamo inimicati una miliardo e mezzo”. No, io vivo a Beirut, sono cittadino di tutta questa città”.
La definizione che il suo amico Samir Kassir ha dato di Beirut, metropoli, araba, occidentalizzata, mediterranea, credo che Frangieh la vivesse come una definizione che lo comprendeva. Vestiva sempre secondo il nostro stile, con giacca e cravatta, e preferiva scrivere in francese piuttosto che in arabo, ne era più padrone nella scrittura, avendo studiato per tanti anni a Parigi. Ma una mattina del 2012, se ben ricordo, nella quale avevamo appuntamento verso le dieci ovviamente a casa sua, mi ha raggiunto in salotto avvolto in un bisht, il mantello nero tradizionale degli arabi, quello che l’emiro del Qatar posò sulle spalle di Messi in occasione della premiazione dopo la vittoria argentina dei mondiali disputati in Qatar. Quello sarà stato particolarmente prezioso, mantello estivo e da emiro, ma, per capirci, è quell’indumento lì. Lo guardai con sorpresa e gli chiesi come mai. E così mi ha raccontato che una volta, durante la guerra civile, andò a trovare un amico che si era trasferito da anni a Parigi, con la famiglia. Gli chiese se tutto andava bene, e nei ripetuti «sì, tutto bene», sentiva che, sotto sotto, si nascondeva un problema. Così attese che le altre persone presenti uscissero e gli rinnovò la domanda: «tutto bene?». Lui rispose ancora di sì, ma poi aggiunse che sua figlia si stava per sposare, con un francese. Bravissima persona, aggiunse, proprio un bravo giovane, di ottima famiglia. Bene, lo incalzò Samir, cosa può esserci che non va? Sai, rispose l’amico, non mi vedo qui per tutta la vita, con quella fettina di carne nel piatto… Frangieh si fermò un momento per guardarmi e visto che non avevo capito mi disse: “Da noi, i piatti che si servono per un pranzo offerto in casa a degli amici sono numerosi, magari meno abbondanti che da voi, ma si portano i piatti di portata in tavola e ognuno sceglie quel che gli va: prenderà un po’ più di questo, un po’ meno di quello, e non toccherà il terzo, o il quarto, che non gli piace. Da voi in Europa non funziona così, si porta un piatto, magari si serve a ognuno la sua porzione. Questo discorso banale ci porta a un discorso molto importante: per tre secoli avete marciato verso quello che Claude Guillebad chiama l’io sovrano. Una conquista che si è progressivamente unita a un sentimento di solitudine: perché quando l’individualismo diventa sistema regolatore, dogma, prima o poi arriviamo a percepire, a comprendere che è contro l’individuo. L’io sarà sovrano, ma anche intimamente orfano. Per lui il mondo arabo doveva marciare verso la liberazione dagli Stati totalizzanti, mentre noi dovremmo ripensare la nostra come marcia verso una modernità meno individualista. « Nella nostra lingua – mi ha spiegato – la parola individuo non esiste. Usiamo tradurla con il termine fard: ma fard non vuol dire “individuo”, bensì “uno di una coppia”. Ognuno di noi si completa in un altro, è questo il motivo per cui le persone qui hanno una specie di secondo nome, e vengono chiamate dai conoscenti “padre di tizio”, o “madre di caio”, anche se non hanno un figlio. Arafat ne ebbe una soltanto in tarda età, eppure per tutti era stato per decenni “Abu Ammar”, cioè “il padre di Ammar”. La solitudine di cui parliamo ci ha destrutturato come persone anche qui, in Libano. E così diventa molto interessante renderci conto di quel che è accaduto sotto i nostri occhi, a Beirut. Da molti anni gli immigrati siriani sono diventati numerosi, ben prima del 2011. Sono stati i nuovi “miserabili” perché hanno vissuto in condizioni miserabili, come fossero dei non esseri umani. E noi, abbiamo provato pietà, commiserazione? Assolutamente no! “Ci portano via il lavoro, creano problemi di sicurezza”, questo è ciò che si diceva di loro.»
Poi nel suo ragionamento, la Primavera ha svegliato gli arabi, siriani e libanesi, dall’annichilimento nel quale vivevano soli e impauriti, nella rimozione della realtà disumana nella quale entrambi vivevano. Di lì un’inattesa empatia tra libanesi e nuovi profughi siriani, quelli giunti dopo il 2011, espulsi perché insorti contro Assad. Il collasso economico del 2019 ha poi portato la maggioranza della popolazione libanese sotto la linea di povertà, riportando a galla il pregiudizio, l’astio, ma il suo ragionamento restava: se il risentimento verso i siriani era stato superato nella comune ripulsa del regime criminale, che tanto ha fatto soffrire siriani e libanesi, perché in condizioni sociali ammissibili non dovrebbe essere pensabile un rapporto “risolto” anche tra arabi e europei, libero dal complesso del maestro e del discepolo, che tanto male ha fatto, anche qui, a entrambi? E allora qui vediamo che oggi, con il rifiuto dei cosiddetti clandestini, pur essendo chiaramente vittime, il problema restano loro, rivestiti dall’abito di “musulmani”. Perché il problema ai nostri occhi è l’islam, non i regimi, che non
conosciamo, perché nessuno ci racconta come siano. Per Frangieh invece era vero il contrario; il problema non è l’islam, ma i regimi. Anche per questi motivi, la sfida all’io sovrano e la ricerca di un rapporto risolto tra arabi ed europei, lo inducevano a ritenere necessario tornare all’intuizione di Jean Corbon e padre Youakim Moubarac, che già prima della guerra civile libanese avevano proposto ai cristiani di definirsi arabi per “lavorare con l’islam al rinnovamento dell’Oriente cristiano e musulmano”, definendo anche una relazione nuova con la Chiesa d’Occidente.
« Questo grande prete libanese, fine intellettuale e collaboratore di Massignon e Gardet, era convinto che la Chiesa d’Occidente, dopo essersi fatta più filosofica, più giuridica e più gerarchica, avverte anche il bisogno di tornare al suo Oriente, di rinnovarlo. Quindi anche la Chiesa d’Occidente ha bisogno di arabi e cristiani, della Chiesa della società araba, del mondo arabo ed anche della Chiesa dell’islam, della società musulmana. Una Chiesa che vive in questo mondo arabo e musulmano, che interagisce con esso, soffre con esso e con esso gioisce, costruisce e spera, crede e ama». Questi ricordi si uniscono a molti altri, il primo dei quali riguarda una sua critica fondamentale ai falangisti cristiani, la milizia guidata da quel Gemayel cui si è fatto cenno. Per Frangieh la devastazione totale del centro di Beirut, di quei palazzi in stile Neo Orientale che davano al centro di Beirut un senso tutto particolare, arabo ed europeo, con suoi affacci ed i suoi vicoli stretti – nonostante il fallito e goffo tentativo del colonialismo di metterci sopra una copia di Place de l’Etoile, con le sue strade a raggiera che partono dalla piazza circolare ma si fermano nelle sue immediate vicinanze in diversi casi per la presenza di scavi romani o di luoghi di culto inamovibili – aveva preso di mira un modello di città euro-araba, un felice esempio di incontro, popolare per tutti le diverse comunità libanesi: a questo modello di città i falangisti dichiararono guerra, perché volevano un centro in perfetto stile europeo! Questo era stato a suo avviso il loro errore, e poi gli altri per combatterli li hanno seguiti. Questa intuizione mi ha portato al punto. Che guerra è stata la vostra guerra civile? La sua risposta spiega la profondità e il valore di ciò che schematicamente ho appena riferito.
« La guerra libanese è stata ricca di insegnamenti, perché la violenza non obbedisce alle norme conosciute. E infatti la nostra non è stata una guerra d’indipendenza o una guerra identitaria, o una guerra etnica, o una guerra comunitaria. È difficile classificarla perché è stata una guerra che comprende tutte queste guerre. È stata una guerra tra Stati, ma anche una guerra di liberazione nazionale, una guerra comunitaria, tra cristiani e musulmani, ma anche una guerra civile all’interno delle comunità. È stata la guerra di Israele nel nome del suo progetto di alleanza delle minoranze contro la maggioranza musulmana, ma anche la guerra della Siria nel nome della Grande Siria nelle sue frontiere storiche. I nomi per classificare questa guerra variano da una fase all’altra, l’unica costante è la violenza, alimentata dalla memoria storica caricata di tutti i malesseri del passato. Ecco perché “violenza” è la parola rimossa. Si parla di aggressione, reazione, complotto, rappresaglia, legittima difesa, resistenza, vendetta… Anche i concetti che noi di sinistra usiamo attualmente, e cioè “lotta di classe”, “guerra di liberazione nazionale”, “violenza rivoluzionaria”, dimostrano tutti i loro limiti. Il fatto è che la violenza ha un valore mimetico, come spiega René Girard, così che ognuno diviene il doppio speculare del suo antagonista. La violenza dunque si fonda sulla reciprocità, ma sommando momenti non reciproci: perché gli antagonisti non occupano mai la stessa posizione contemporaneamente, ma successivamente. Ecco allora che solo una rinuncia incondizionata alla violenza può salvarci dalla “violenza mimetica”. Queste idee di René Girard hanno dato un nuovo indirizzo al mio impegno per il dialogo. Tra cristiani e musulmani, tra libanesi e libanesi, tra libanesi e siriani. Per fermare la violenza infatti cosa dobbiamo fare? Raggiungere un cessate-il-fuoco? Fare la pace? Ma quale pace? Una pace gloriosa, la pace dei coraggiosi, o una pace banale, meschina? E in questo caso che fine faranno i grandi principi nel nome dei quali ci siamo allegramente massacrati per decenni? Mi è servito molto tempo per capire che il contrario della “violenza” non è la pace, cioè la pace tra comunità, ma il legame, il legame tra individui appartenenti a diverse comunità o gruppi. Così ho capito che pacificato il Paese, l’obiettivo del nostro dialogo non doveva più essere quello di cercare un compromesso, ma di definire un progetto di vita in comune. Ecco l’idea del vivere insieme, profondamente diversa da coesistenza comunitaria.»