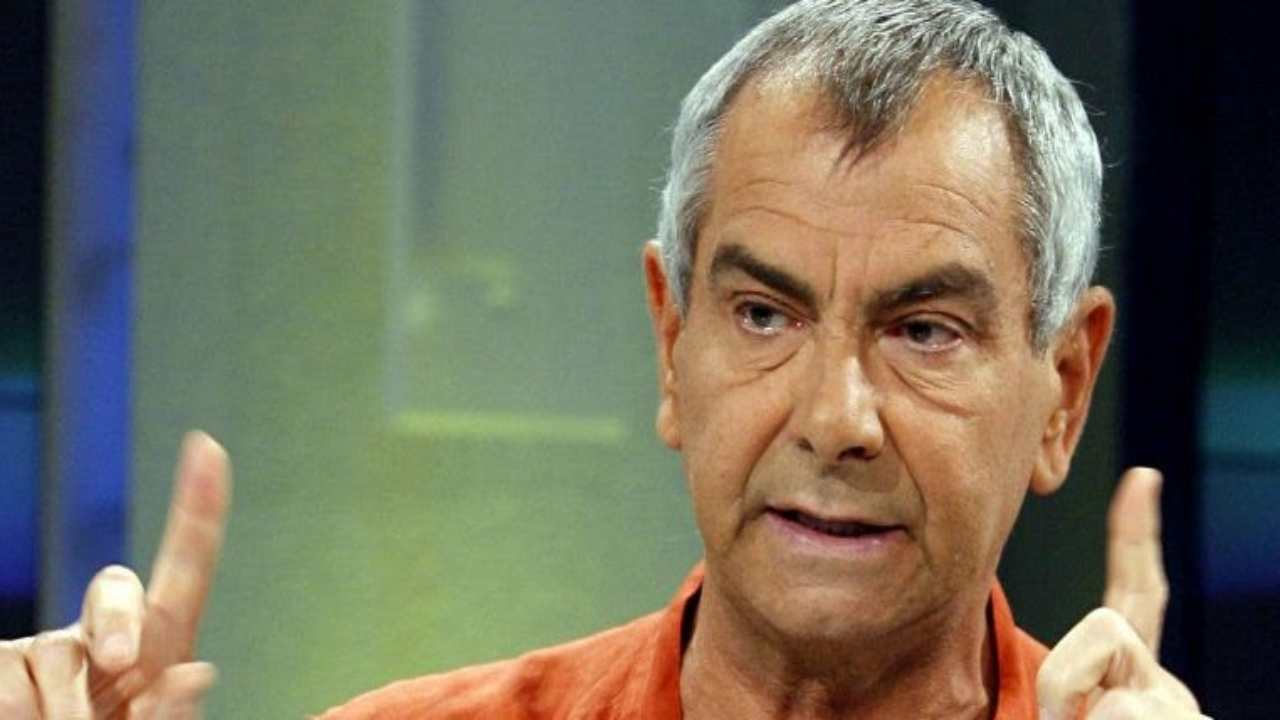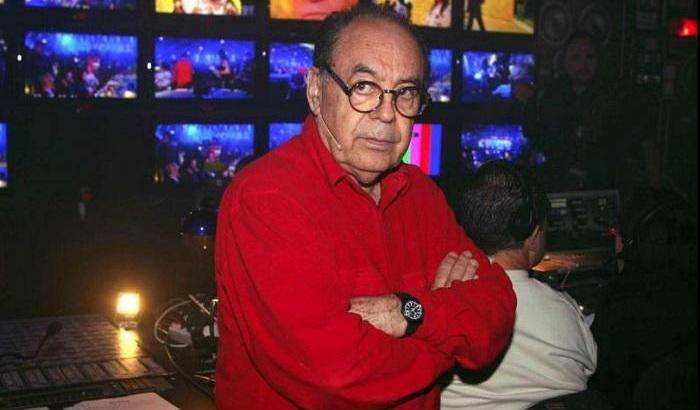di Antonio Salvati
Insegnalo bene ai tuoi genitori
L’inferno dei loro figli passerà lentamente
E nutrili con i tuoi sogni
(…)
E tu, in tenera età
Non posso conoscere le paure in cui sono cresciuti i tuoi anziani
Aiutali con la tua giovinezza
Teach your children, Brano di Crosby, Stills, Nash & Young – 1970
Dopo diverse sollecitazioni di amici e colleghi ho visto la miniserie anglosassone Adolescence che sta riscuotendo un meritato successo. Anch’io – come credo tanti – al termine della visione ho provato commozione insieme ad un forte senso di smarrimento. Ed è vero che – come ha osservato Massimo Calvi – avverti immediatamente un pressante bisogno di parlarne. Di condividere il disagio con altri – magari genitori o insegnanti come te – che provoca la vicenda del 13enne Jamie Miller (magnificamente interpretato dal giovanissimo Owen Cooper) accusato d’omicidio di una sua coetanea. Il bisogno di attenuare quella sensazione di sgomento scaturito anche per via di quel tipico processo di immedesimazione – come accade nel corso della lettura di un buon romanzo – verso i protagonisti adulti della serie incapaci di individuare i segni premonitori della violenza nei giovani. Una vicenda che ancora una volta mette in rilievo – qualora ce ne fosse stato bisogno – la deriva possibile di una società in cui non esiste più una comunità educante. Per questo, abbiamo bisogno di parlarne. Magari con l’ausilio di riferimenti autorevoli e con la consapevolezza che nessun destino è preordinato e che tra i nostri giovani c’è molta più speranza di quanto una serie tv possa raccontarci.
Tutte le ragazze e tutti i ragazzi hanno un estremo bisogno di una madre, di un padre o di un insegnante che li ascolti autenticamente e stia in relazione con loro. Potrebbe essere un’ovvietà, ma non lo è. In una società in cui molti adolescenti scelgono di allontanarsi, la vera speranza, quella che può davvero fare la differenza nella vita di ciascuno, risiede proprio nella relazione. Lo ripete da anni Matteo Lancini che nel suo ultimo volume, Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti(Raffaello Cortina Editore 2025, 216 pp. € 16,00), ci ricorda che «un numero crescente di giovani (si stima tra il 5 e il 15 per cento degli adolescenti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità) che soffre di solitudine o, come sempre più spesso accade, di solitudini al plurale – da quella emotiva, che si manifesta quando mancano legami profondi e intimi, a quella sociale, che emerge dalla povertà di interazioni e di contatti con gli altri, a quella esistenziale, la più profonda e insidiosa, che porta a svalutare la propria vita, anche se si è circondati da amici o persone care». Ognuna di queste non solo genera un’angoscia indicibile, ma comporta anche gravi rischi per il benessere e la salute, fisica e mentale, dell’individuo. Tra questi, l’OMS cita malattie cardiache, depressione, disturbi del sonno e dell’appetito, un aumento della suscettibilità a malattie fisiche dovute allo stress e a uno stile di vita malsano, oltre a un indebolimento del sistema immunitario, cardiovascolare ed endocrino.
Le ragazze e i ragazzi del nuovo millennio sperimentano un pervasivo conflitto tra aspettative ideali, edificatesi lungo le strade dell’infanzia, e cosa si diventa e si è davvero al momento della seconda nascita sociale e del corpo. Adolescenze in cui – questo è il punto nodale – «non ci sente mai abbastanza belli, mai abbastanza popolari», come accade a Jamie. I sentimenti prevalenti del disagio odierno – ha scritto Lancini in Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti (Utet 2020 pp. 110 € 14) – sono la vergogna e una rabbia spesso non espressa, per il mancato successo e la delusione inferta a sé e ai propri genitori. Sentirsi brutti, inadeguati, impopolari «non è certo facile da elaborare se provieni da un universo infantile fatto di anticipazioni e aspettative e devi avanzare in una società dell’immagine, dei social, della notorietà a tutti i costi e dell’individualismo». Nella miniserie ciò appare evidente nei colloqui avvenuti all’interno della struttura carceraria tra Jamie e la psicologa. E colpisce la disperazione di Jamie quando la psicologa lo informa che sono terminati i loro incontri. Per Jamie viene meno la possibilità di continuare di avere una relazione significativa che lo aveva aiutato a meglio comprendere quanto accaduto. In realtà, i nuovissimi adolescenti «non hanno alcuna intenzione di confliggere con gli adulti e, anzi, ricercano più che in passato figure autorevoli capaci di sostenerli nel percorso evolutivo adolescenziale. A patto che li si tratti per quello che sono, non per quello che è lo stereotipo dell’adolescenza che spesso abita la mente di generazioni adulte cresciute con il mito dell’invidia del pene, del testosterone maschile, delle mestruazioni di cui vergognarsi, della sessualità repressa e della ribellione giovanile». Oggi gli adolescenti non sono trasgressivi, non sono dominati dalla colpa. Conviene – spiega Lancini – accettare questo dato: «la trasgressione non esiste più, il problema centrale dell’adolescente del nuovo millennio è la delusione. Se in passato la strada maestra per realizzare i compiti evolutivi adolescenziali era la trasgressione alla norma e alla regola, oggi si cresce affrontando la delusione. Nessun adulto da abbattere, nessuno stato, chiesa, padre, norma superegoica da contrastare ma aspettative ideali su di sé, talmente elevate da risultare irraggiungibili». In questo modo gli adulti spesso perdono credibilità, perché si relazionano e utilizzano dispositivi educativi adatti al funzionamento adolescenziale di qualche decennio addietro.
Non a caso, la storia della miniserie segue la famiglia Miller mentre affronta lo shock dell’accusa contro Jamie e le conseguenze devastanti sulla loro vita quotidiana. Esplora anche il punto di vista degli investigatori e degli psicologi coinvolti nel caso. Anch’essi sono impressionati, chiedendosi cosa può aver portato un ragazzo apparentemente normale a un atto così estremo. L’investigatore inizia a dubitare di tutto ciò che pensava di sapere su suo figlio e desidera uscire con lui. Anche i media e le piattaforme social giocano un ruolo cruciale nel caso e soprattutto nella storia di Jamie.
Si ricava l’impressione che ciò che risulta più difficile non è tanto ascoltare, quanto – direbbe Lancini – permettere che le parole del dolore penetrino davvero dentro di noi e«abbiano il tempo di radicarsi nella mente e nel cuore, affinché possano entrare in dialogo con le nostre emozioni e i nostri sentimenti più profondi». È faticoso – riconosciamolo – lasciare attecchire le emozioni negative dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze dentro di noi. Come è difficile trasformarle «nei semi in grado di far germogliare nella nostra pancia la pianta dello stare, che, come la ginestra di leopardiana memoria, è splendida e lucente, e ha radici profonde e intrecciate, in grado di resistere e ancorarsi in profondità al terreno che le circonda». Possiamo stare nella relazione, avverte Lancini, anche se non riusciamo a metterci comodi, «anche se non siamo adagiati sui morbidi cuscini degli affetti più caldi, avvolgenti e rassicuranti». Si, possiamo stare. È possibile. Stiamo. Stiamo fermi e in ascolto, attenti, concentrati. Anche con la sensazione di avere appena ricevuto una pallonata in faccia, come dopo aver visto Adolescence. Stiamo a sentire – «e non solo le parole che i ragazzi hanno da dire e che rivolgono a noi adulti. Parole sgrammaticate, impensabili, a volte prive di senso, almeno in apparenza, prive di speranza e vuote. Vuote rispetto al pieno di vita di cui vorremmo che loro fossero testimoni, che riteniamo di aver erogato dal nostro distributore di amore, attenzioni e risorse. Stiamo a sentire quanto male hanno dentro e quanto fa male a noi. La loro rabbia, la loro fatica, l’assenza di prospettive, di amici, di una qualsiasi visione arriva e ci trafigge come una lama in mezzo al petto». Come qualcosa che ci toglie il fiato. Ma anche questa è vita. Certo, spesso fa male. Attraversare intensamente il dolore è la prima esperienza che incontriamo per stare nel mondo, per vivere. Come quando le donne che diventano madri si contorcono nelle doglie, nel parto, mentre stanno generando la vita. «Quello dei figli è un dolore che prende il corpo, lo sovrasta, ma è come un’onda gigante e travolgente. Possiamo resistere, lasciarci travolgere, ma restando piantati profondamente dentro di noi, saldi e sicuri che, con la stessa intensità, esso evolverà, si trasformerà, non a modo nostro ma a modo loro. Non serve andarsene altrove, con la mente o fisicamente, ma serve restare lì accanto, vicino, sintonizzati sulle loro frequenze, senza cedere alla tentazione di cambiare canale, come di fronte a un film dell’orrore o a un programma che non ci piace. Se nella vita abbiamo cercato di essere sempre un esempio di impegno, forza e dedizione, è naturale sperare che queste qualità trovino riscontro nelle esperienze dei nostri figli».
Per Bergoglio l’adolescenza non è una patologia che dobbiamo combattere. Fa parte della crescita normale, naturale della vita dei nostri ragazzi. «Dove c’è vita c’è movimento, dove c’è movimento ci sono cambiamenti, ricerca, incertezze, c’è speranza, gioia e anche angoscia e desolazione», afferma Papa Francesco. Anche l’inquietudine è connaturata a questa fase della vita: «So che c’è qualcosa, nei vostri cuori, che vi rende inquieti, perché un giovane che non è inquieto è un vecchio», disse il Papa nel luglio del 2016. Ero presente il 19 giugno 2017, quando Papa Francesco aprendo i lavori del convegno diocesano di Roma, a proposito dei giovani invitava a seguire il ritmo della loro crescita per «aiutarli ad acquisire autostima, a credere che realmente possono riuscire in ciò che si propongono». Aggiungeva che questo processo esige di sviluppare in maniera simultanea e integrata i diversi linguaggi che ci costituiscono come persone, ossia insegnare ai nostri ragazzi a integrare tutto ciò che sono e che fanno. «Potremmo chiamarla una alfabetizzazione socio-integrata, cioè un’educazione basata sull’intelletto (la testa), gli affetti (il cuore) e l’agire (le mani). Questo offrirà ai nostri ragazzi la possibilità di una crescita armonica a livello non solo personale, ma al tempo stesso sociale. Urge creare luoghi dove la frammentazione sociale non sia lo schema dominante. A tale scopo occorre insegnare a pensare ciò che si sente e si fa, a sentire ciò che si pensa e si fa, a fare ciò che si pensa e si sente. Cioè, integrare i tre linguaggi. Un dinamismo di capacità posto al servizio della persona e della società. Questo aiuterà a far sì che i nostri ragazzi si sentano attivi e protagonisti nei loro processi di crescita e li porterà anche a sentirsi chiamati a partecipare alla costruzione della comunità». Vogliono essere protagonisti. Allora «diamo loro spazio perché siano protagonisti, orientandoli – ovviamente – e dando loro gli strumenti per sviluppare tutta questa crescita. Per questo ritengo che l’integrazione armonica dei diversi saperi – della mente, del cuore e delle mani – li aiuterà a costruire la loro personalità. Spesso pensiamo che l’educazione sia impartire conoscenze e lungo il cammino lasciamo degli analfabeti emotivi e ragazzi con tanti progetti incompiuti perché non hanno trovato chi insegnasse loro a “fare”. Abbiamo concentrato l’educazione nel cervello trascurando il cuore e le mani. E questa è anche una forma di frammentazione sociale».
Sono parole preziose ed adatte al tempo presente per genitori e adulti spaventati e non. Per cercare insieme ai nostri figli, ai più giovani di guardare al futuro con speranza.
Antonio Salvati