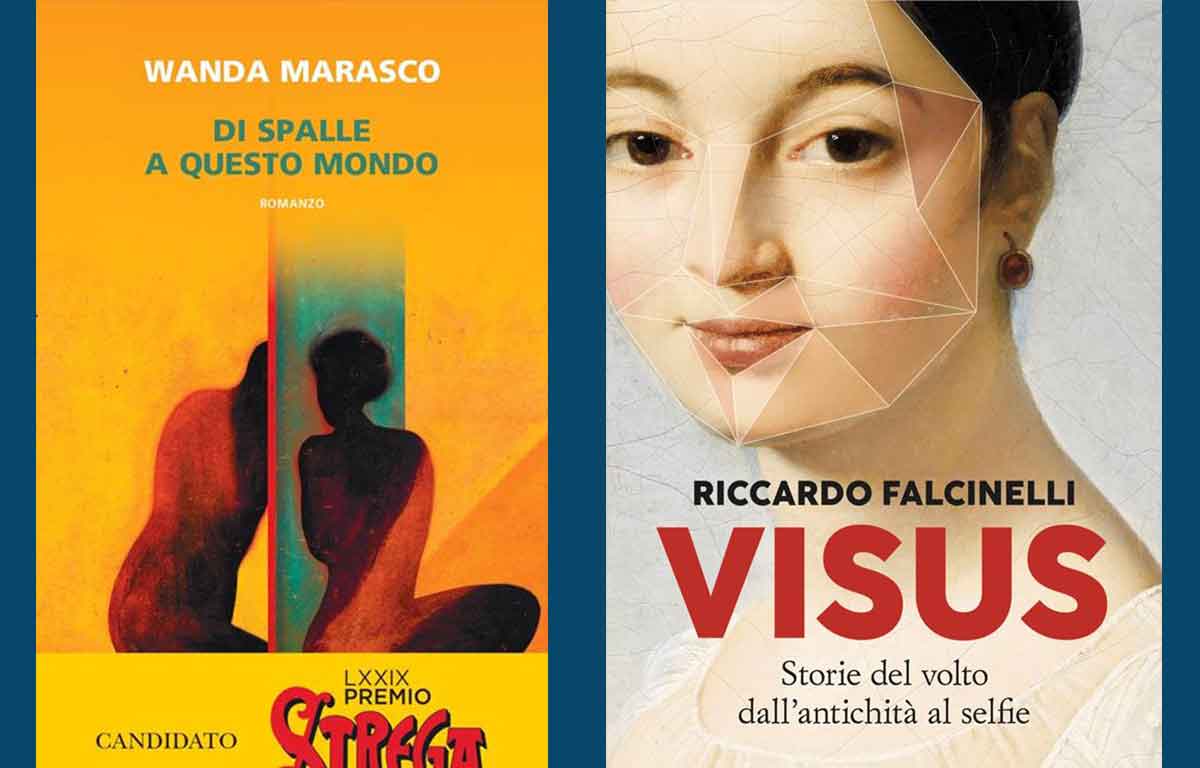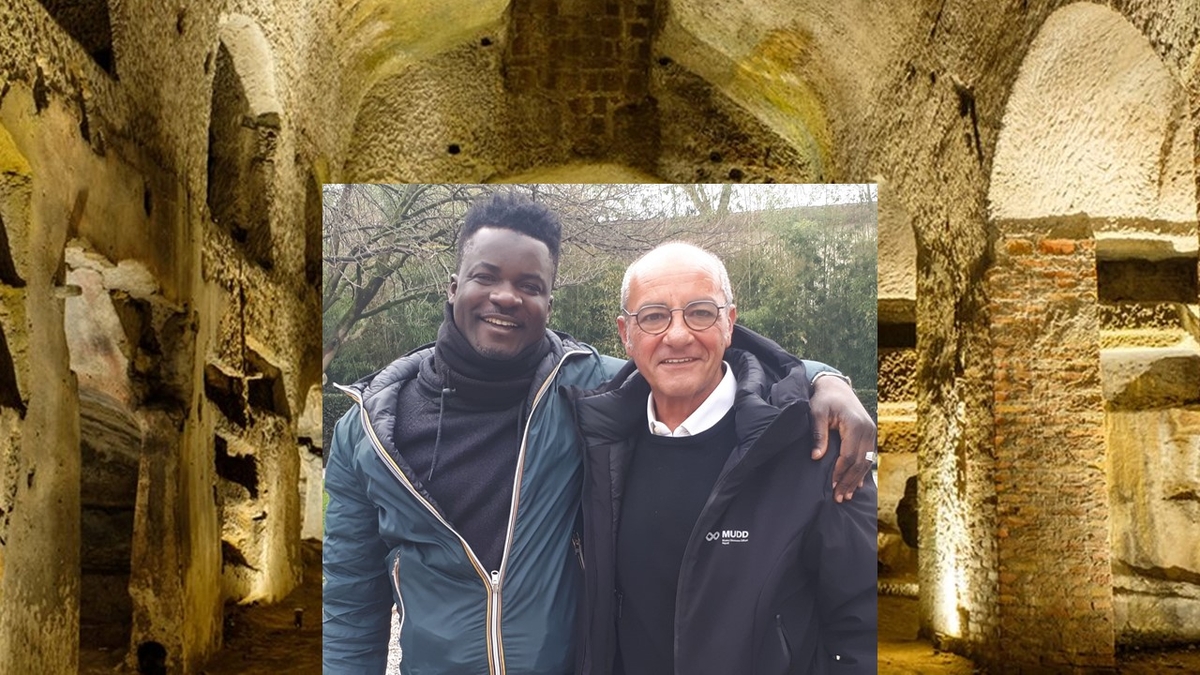di Alessia de Antoniis
Nessun applauso alla fine della proiezione al cinema Barberini di Roma di No other land. Persone rimaste sedute. Volti segnati da quanto appena visto. Poi una sorta di processione funebre: ad uno ad uno si sono alzati, muti, dirigendosi verso l’uscita della sala; a capo chino.
Quella al Barberini è stata una delle oltre 40 proiezioni del documentario premio Oscar 2025 No Other Land, organizzate domenica 30 marzo da Alice nella Città, Every Child Is My Child, Unita, 100 Autori, WGI – Writers Guild Italia, Wanted Cinema, insieme a una rete in costante espansione di associazioni, artisti e professionisti del cinema e della cultura, per annunciare la nascita di Humanland, un progetto collettivo di resistenza, solidarietà e testimonianza.
No Other Land è il film documentario del 2024, opera del collettivo israelo-palestinese di cui fa parte Hamdan Ballal, recentemente rapito e picchiato e fortunatamente liberato, Basel Adra, Yuval Abraham e Rachel Szor. No Other Land racconta con forza e umanità le demolizioni di Masafer Yatta, in Cisgiordania, a opera dell’IDF. Vedere No other land è un gesto politico e culturale, un invito a restare uniti, umani, e a non girarsi dall’altra parte.
“Trattano gli arabi con ostilità e crudeltà, li picchiano senza motivo e si vantano delle loro azioni. Nessuno li ferma. Queste parole non sono state scritte oggi, ma nel 1891, da Asher Ginsberg”. Con queste parole Lorenzo Kamel, professore di Storia internazionale all’Università di Torino e autore del libro Israele – Palestina, edito da Einaudi, ha aperto l’introduzione alla proiezione.
No other land, con le sue immagini crude, “non giustifica in alcun modo la violenza cieca del 7 ottobre, che va condannata senza riserve. Ma senza conoscere la storia, si producono solo narrazioni che disumanizzano l’altro” – ha concluso Kamel.
“Ho 5 anni. Il mio primo ricordo: mio padre arrestato per la prima volta. Ho 7 anni: la mia prima protesta, seduto in terra con mia madre”. Inizia così No other land, girato tra il 2019 e il 2023, ambientato a Masafer Yatta, un conglomerato di 13 villaggi palestinesi nel sud di Hebron, nell’Area C della Cisgiordania. Un posto dove, da oltre 50 anni, milioni di persone vivono senza Stato né cittadinanza; dove milioni di palestinesi sono soggetti a tribunali militari israeliani, con un tasso di condanna del 99,74%; dove ci sono tribunali militari per ragazzi dai 13 ai 15 anni. Questo significa nascere e crescere nell’area C della Cisgiordania.
“Hanno sparato a mio figlio davanti a me”, dice una donna accanto a un figlio reso tetraplegico da un soldato israeliano che ha sparato a sangue freddo mentre veniva ripreso. La sua colpa? Aver cercato di difendere l’unico generatore di corrente portatile che avevano.
Quello che scorre sullo schermo sono riprese di vita quotidiana: soldati israeliani che arrivano, radono al suolo con le ruspe, sparano a chi si oppone e vanno via. I palestinesi ricostruiscono. I soldati dell’IDF tornano, le ruspe radono al suolo e vanno via. “È la legge”, ripetono soldati e soldatesse, privi di empatia, privi di umanità. I soldati di Israele, il popolo eletto da un dio, quello stesso popolo che dovrebbe avere nelle Tavole della Legge il fondamento del loro Stato.
La Legge: Non uccidere. Non rubare. Non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo (…) né il suo bue né il suo asino né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Così nel libro dell’Esodo.
“Non mi hanno lasciato prendere niente”. “Ci sono centinaia di ordini di demolizione. La gente non sa dove colpiranno oggi. E in tv dicono che stiamo costruendo illegalmente”. “Ci stanno distruggendo lentamente”. “Ci hanno resi stranieri nella nostra terra”. Così le voci di chi assiste impotente allo sterminio della sua famiglia, amici, vicini; a un genocidio programmato.
“Questa casa è mia”: è così che dice chi abita in quella terra da secoli ai coloni armati che arrivano scortati dall’esercito israeliano. “No, questa non è casa tua”. Pollai e recinti per capre distrutti, soldati che divelgono con disprezzo impianti di irrigazione. C’è un senso di ineluttabilità nei discorsi degli abitanti di Masafer Yatta.
Un senso di impotenza ti pervade mentre vedi le immagini di una betoniera che getta cemento su un pozzo per l’acqua, perché anche l’acqua del sottosuolo dei territori occupati della Cisgiordania appartiene a Israele. La stessa impotenza con cui guardi evacuare una scuola con bambini delle elementari che assistono attoniti alle ruspe che la radono al suolo. Distruzione, ricordi persi tra le macerie, carri armati sui campi coltivati, spari, morti. Ogni giorno. Ogni notte. Questo è ciò che resta negli occhi di chi vive in Palestina e nei “territori occupati”. Occupati. Occupo ciò che non mi appartiene. Mentre un popolo che abitava lì, ricostruisce ogni volta, va ad abitare nelle grotte, prova a ricominciare daccapo, consapevole che lasciare quella terra significa perderla.
Non uccidere: da quell’orribile 7 ottobre 2023 i morti palestinesi potrebbero essere più di 50 mila.
No other land non è un semplice documentario ma un atto di memoria e resistenza: non si limita a informare, ma chiama a un’azione. Nonostante l’uso di cellulari o handycam per le riprese, è costruito per coinvolgere il pubblico, per immergerlo nella realtà di Masafer Yatta, per arrivare alla parte emozionale di chi guarda, alternando momenti intensi e momenti di riflessione. Un film che ti lascia addosso la sensazione che forse è ora di smettere di parteggiare per gruppi, etnie, religioni. Che siamo tutti parte di una sola razza: quella umana. Che prima o poi a chiunque potrebbe accadere di sentirsi dire: “Hai un altro posto dove andare?” e dover rispondere “No, no other land”.
Argomenti: Cinema