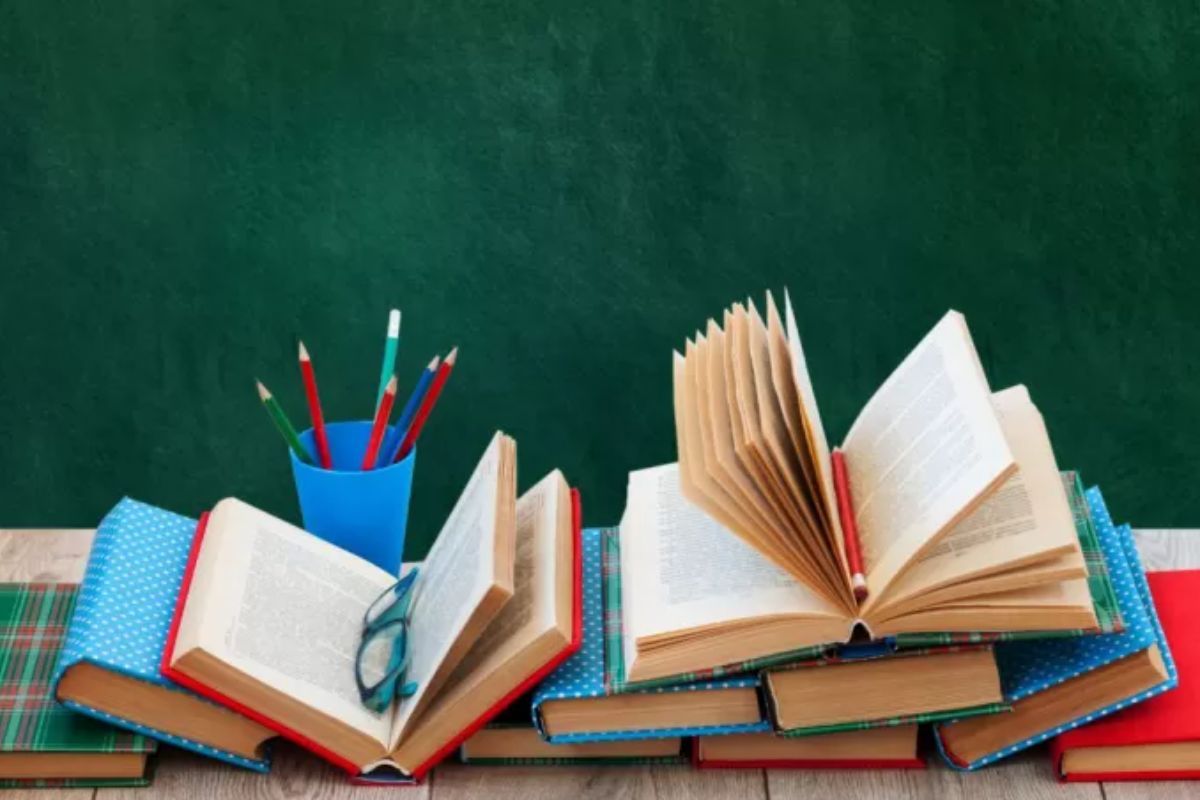di Antonio Capitano
Siamo a Roma, in via della Maschera d’Oro. E’ il 17 agosto del 1603 e nell’abitazione di un giovane facoltoso e lungimirante si stava scrivendo una importante pagina di storia. Questo straordinario diciottenne era Federico Cesi e “in un’atmosfera quasi di congiura, di giuoco segreto e dopo polemico però provvisti in corpore dell’occhio della lince per guardare oltre e avventurarsi in quello che veniva chiamato “il gran theatro della natura” nasceva l’Accademia dei Lincei.
Gli altri tre fondatori erano: un suo cugino ternano Anastasio de Filiis, un suo amico fidato di Fabriano, Francesco Stelluti e l’olandese Johannes van Heeck.
Basterebbe solo riflettere su questo speciale incontro per comprendere con quale portata dei “ragazzi” promettenti e visionari non solo progettavano il loro futuro, ma al tempo stesso ne anticipavano uno luminoso per la conoscenza con “Il natural desiderio di sapere”. Qui siamo di fronte alla volontà di agire, attraverso una vigile disciplina e con metodi precisi, per un lavoro associato nell’affascinante e impegnativo microcosmo della ricerca con la promessa di “conservare fra noi reciproco amore e scambievole consuetudine; a recarci aiuto l’un l’altro in ogni cosa; a professare il nome di Linceo in tutte i nostri doveri di studio e specialmente nelle nostre pubblicazioni”. Ma c’è un passo che oggi acquista un valore speciale “il fine dell’Accademia dei Lincei non è soltanto acquistare conoscenza e sapienza, vivendo insieme rettamente e piamente, ma diffonderle fra gli uomini, a voce e con gli scritti, pacificamente, senza recare danno a nessuno”. Si tratta di un vero e proprio manifesto civile per dirigere le azioni, avendo cura di rispettare persone e pensieri, confinando le personali ambizioni nell’alveo della reciproca libertà intellettuale e creativa, senza sgomitate e senza scorciatoie o per dirla ancora con le loro parole “in pace, quiete, concordia, senza nessuna ira, invidia, desiderio di emulazione”. Da queste “semplici” premesse si rende già l’idea della grandezza degli intenti e delle idee che meriterebbero una riflessione ben più ampia, affrontando ogni singolo aspetto.
Tuttavia, per nostra fortuna, alcuni aspetti peculiari continuano ad essere divulgati quali ad esempio quelli affrontati in un importante convegno 400 anni dalla donazione dell’Occhialino di Galileo Galilei a Federico Cesi
Il termine del “nuovo” strumento anticipava il primo microscopio della storia utilizzato per scoperte scientifiche nei Monti Lucretili, con il Pratone di Monte Gennaro, ribattezzato “Anfiteatro Linceo”. Anche le vicende legate alla denominazione sono motivo di interesse e ricerca, alimentando quello studio intorno alle parole per renderle maggiormente conformi alla realtà. Questa operazione costituisce un significativo approccio linceo poiché dietro e dentro le parole ci sono mondi da scoprire e fiumi navigabili per incontrarne tutti gli affluenti. Forse il Linceo più noto fu proprio Galileo che incontrò Cesi nella primavera del 1611, nell’occasione di un viaggio dello scienziato pisano a Roma per divulgare e difendere le proprie scoperte che vedevano “oltre” il suo tempo in un noto chiaroscuro storico ripreso anche dal “biografo” Brecht. Siamo giunti al 25 aprile del 1611, data che nel corso dei secoli assunse un moderno significato di Liberazione, quasi a presumere che scegliere di entrare in questa speciale Accademia fosse una certezza di trovarsi al centro del valore della libertà di pensare e rivoluzionare.
Attraverso l’invenzione galileiana “per vedere da vicino le cose minime”, che i lincei divennero così i padri fondatori della microscopia scientifica. La bellezza di questa scoperta è la bellezza della scoperta, della ricerca, di continuare a credere che vedere le piccole cose aiuta a capire le grandi. Grandi come questi nomi che ancora continuano a suscitare motivazioni per elevare l’animo e lo spirito attraverso il dono della conoscenza e del desiderio di sapienza, seguendo una cultura della pace e della convivenza civile.