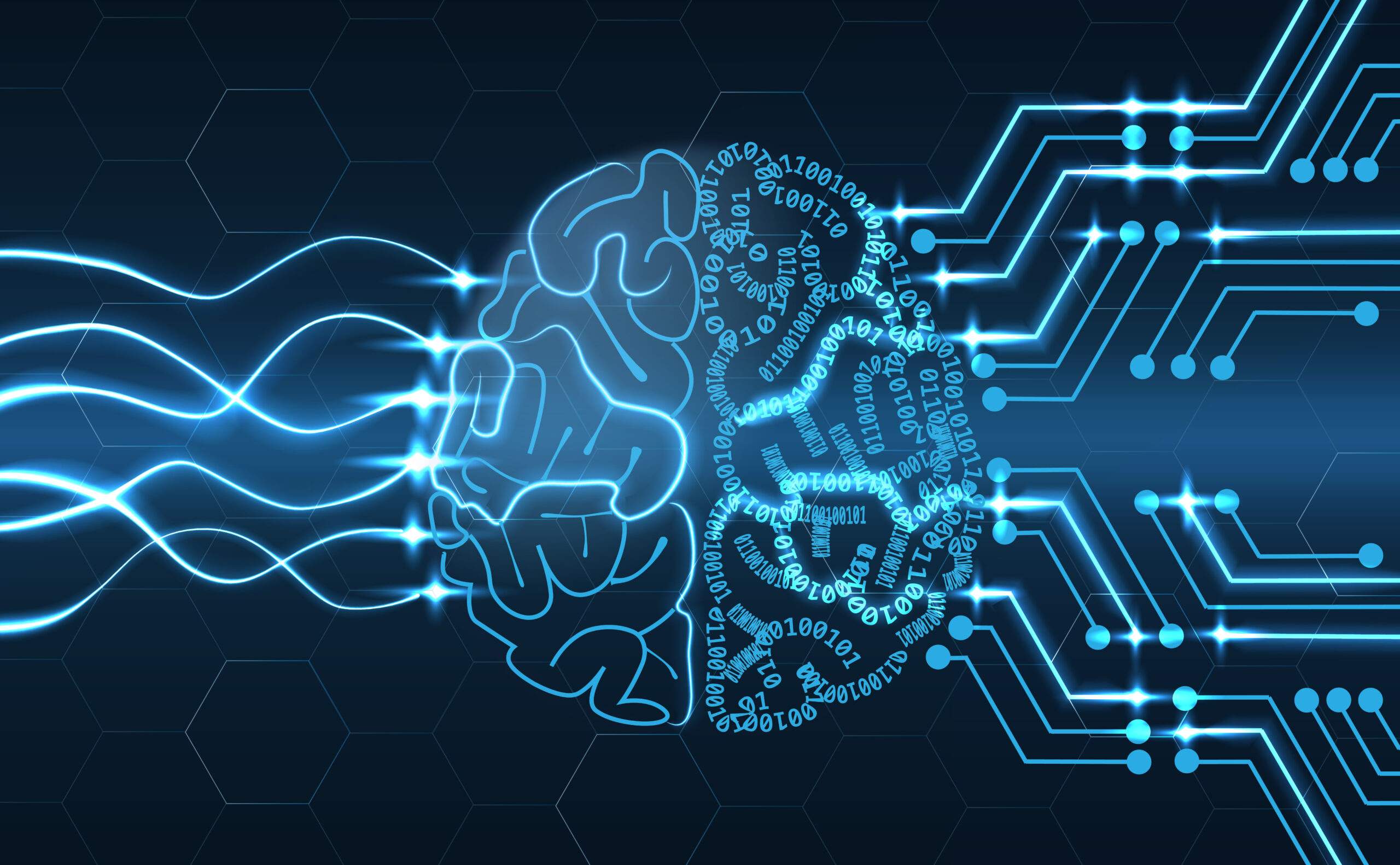di Rock Reynolds
La notizia dell’operazione di Hamas a ridosso della Striscia di Gaza il 7 ottobre è stata data da quasi tutte le fonti di informazione allo stesso modo: «Un feroce attacco terrorista ha seminato morte e distruzione in un rave party e in alcuni kibbutz, scatenando una nuova guerra».
Nessuno che abbia utilizzato espressioni e termini diversi. Nessuno che si sia preso la briga di collocare quell’azione raccapricciante nel contesto di un conflitto annoso e di definire gli uomini che vi hanno preso parte attivamente non come biechi terroristi assetati di sangue bensì come miliziani di un’organizzazione paramilitare in guerra da molto tempo con lo stato d’Israele.
Insomma, la narrazione degli eventi è stata fatta in modo estremamente sbilanciato, facendo quasi un copia e incolla acritico dei dispacci rilasciati dall’ufficio relazione esterne dell’IDF, l’esercito con la stella di Davide.
Mai come in una situazione come quella ci sarebbe stato bisogno di una stampa meno asservita alle direttive americane, israeliane e occidentali. Un seppur tardivo rimedio lo si può sempre trovare. E, nella fattispecie, ha la forma di un libro eccellente, intitolato Il 7 ottobre tra verità e propaganda (Fazi Editore, pagg 154, euro 12), di Roberto Iannuzzi, analista di politica internazionale e ricercatore. Snello, accurato e chiaro su quanto accaduto il 7 ottobre e su quanto successo immediatamente dopo, il libro di Iannuzzi andrebbe letto (forse studiato) nelle scuole. I dubbi sul fatto che si trattasse dell’ennesimo “instant book” creato per approfittare della stretta attualità a scopi commerciali è durato lo spazio di poche righe.
Il 7 ottobre tra verità e propaganda scava con semplicità nella realtà delle cose, sfrondandole delle zone d’ombra costruite ad arte per nascondere l’orrore di una condizione di apartheid che, alla lunga, ha portato alla peggior disfatta militare di Israele e, soprattutto, a una delle reazioni più sproporzionate nella storia bellica internazionale.
Qualcuno potrebbe tacciare Iannuzzi di parzialità. Alla luce di quanto è tuttora in corso a Gaza e pure in Cisgiordania, non credo sia possibile non prendere le difese dei deboli. Credo, peraltro, che si possa farlo mantenendo scientificità. Roberto Iannuzzi ci è riuscito benissimo e lo dimostrano anche le sue risposte alle domande che gli abbiamo posto.
I fatti del 7 ottobre sono stati annunciati dai media internazionali come un apocalittico attacco terroristico, non come un raro caso di vittoria militare palestinese in una guerra in atto da quasi 80 anni. L’una o l’altra cosa?
«In Israele e in Occidente si è teso a dipingere l’azione di Hamas e degli altri gruppi palestinesi (perché Hamas non ha agito da solo il 7 ottobre) come un gratuito e brutale attacco terroristico, condito di atrocità bestiali e truculente, le quali hanno continuato a circolare sui media europei e americani sebbene siano state in gran parte smentite dalla stessa polizia israeliana o da inchieste della stampa di quel paese. Hamas e le altre fazioni palestinesi hanno invece descritto quell’azione come una vittoria militare per mettere in evidenza che dal loro punto di vista si è trattato di un legittimo atto di resistenza contro un’occupazione militare oppressiva e violenta che si protrae da decenni. I miliziani palestinesi hanno colpito anche i civili, oltre ai militari israeliani, e ciò in base al diritto internazionale è un crimine di guerra. Resta il fatto che questo drammatico conflitto, nel quale le vittime palestinesi sono sempre state incommensurabilmente superiori a quelle israeliane, è stato solitamente caratterizzato dall’assenza di demarcazione fra civili e militari. E che Israele si è a sua volta costantemente contraddistinto per l’uso sproporzionato della forza e la scarsa attenzione nei confronti dei civili palestinesi. L’azione del 7 ottobre è stata definita una vittoria dai palestinesi in quanto ha cancellato il mito della potenza militare israeliana e della sua invincibilità. Come tutte le vittorie palestinesi, ha avuto un prezzo altissimo, la pressoché totale distruzione di Gaza (che tuttavia non ha ristabilito la deterrenza israeliana, in quanto Hamas continua a combattere, e le forze di Tel Aviv sono tuttora impegnate su due fronti, essendo state sfidate anche da Hezbollah sul confine libanese). In definitiva, quella del 7 ottobre è stata un’operazione disperata, di fatto suicida, per rimettere al centro dell’attenzione internazionale una questione drammatica quanto dimenticata, quella delle condizioni del popolo palestinese, una questione che rischiava di essere sepolta per sempre dal ventilato accordo di riconciliazione fra Israele e Arabia Saudita, e dal governo Netanyahu nelle cui file militano elementi visceralmente antipalestinesi e dichiaratamente annessionisti».
Ben prima del 7 ottobre, avevo la sensazione che i media avessero rappresentato Hamas sotto una luce di comodo occidentale: una banda di tagliagole assetati di sangue e accecati dall’odio religioso, non a caso definiti terroristi senza nemmeno mai porsi qualche domanda. Non è demonizzando e disumanizzando i volontari dell’IRA che la Thatcher cercò a sua volta di neutralizzarne l’efficienza?
«Esattamente. Demonizzare il nemico serve a giustificare il rifiuto di qualsiasi trattativa, con il pretesto che l’avversario non sarebbe un seppur scomodo interlocutore ma solo un antagonista sanguinario e implacabile. Proprio l’esperienza dell’IRA invece dimostra che è possibile giungere a un compromesso se vi è la volontà politica. Israele questa volontà non l’ha mai mostrata. Al contrario, sono numerose le prove – a cui accenno nel mio libro – che documentano come i successivi governi israeliani abbiano favorito l’ascesa di Hamas proprio per frammentare il fronte palestinese e poter così affermare che non esiste un interlocutore con cui negoziare. La stessa storia di Hamas merita di essere approfondita. Il gruppo nasce addirittura come un’organizzazione nonviolenta ed apolitica, dedita esclusivamente all’assistenza della popolazione palestinese. Solo con la prima Intifada del 1987 aderisce alla rivolta, anche armata, contro Israele. Un’immagine un po’ diversa dallo stereotipo dei tagliagole assetati di sangue».
Secondo lei, com’è possibile che la propaganda israeliana e l’assenso di buona parte dei media internazionali siano riusciti ad assuefare il pubblico alle quotidiane immagini di violenze e sofferenze indicibili?
«La tecnica è sempre la stessa. Vengono ingigantite le violenze di una parte, e sminuite, o addirittura passate sotto silenzio, quelle dell’altra. I mezzi di informazione occidentali non ci hanno mai parlato della quotidiana violenza dei coloni e delle forze di sicurezza israeliane nei territori occupati prima del 7 ottobre. Così come hanno tentato di sminuire la portata della devastazione israeliana di Gaza dopo l’attacco di Hamas, almeno per quanto è stato possibile. C’è poi un’altra differenza chiave. Tutte le vittime israeliane hanno un volto, una storia personale che ci viene raccontata nei minimi dettagli. Le vittime palestinesi sono anonime, senza storia, dei meri numeri, perfino imprecisi. Sappiamo per esempio che il 7 ottobre sono rimaste uccise 1.139 persone (71 stranieri, e il resto israeliani), ma nessuno pensa che quello stesso giorno è morto un numero maggiore di palestinesi, almeno 1.500 miliziani (nessuno sa il numero preciso), ai quali bisogna aggiungere le vittime dei durissimi bombardamenti israeliani iniziati quello stesso giorno sulla Striscia. E le vittime dei mesi successivi a Gaza sfiorano ormai – e forse superano, se si tiene conto dei cadaveri non ancora estratti dalle macerie – la cifra di 40.000 morti. Ad ogni modo, questo è un problema che non riguarda solo Israele, ma l’Occidente nel suo complesso. Solo le vittime occidentali hanno un’individualità, una storia, una dignità di persone. Le vittime non occidentali sono mere statistiche».
L’efficienza dei servizi segreti e delle forze armate di Israele è quasi leggendaria. Non si direbbe, alla luce dei fatti del 7 ottobre…
«Questo è il grande enigma irrisolto del 7 ottobre. Com’è possibile che a Gaza, uno dei territori più sorvegliati del pianeta, Hamas abbia potuto preparare un’operazione di queste dimensioni passando del tutto inosservato? Com’è possibile che l’intelligence israeliana, una delle più sofisticate al mondo, non abbia colto alcun segnale d’allarme? Perché gli avamposti militari attorno alla Striscia erano completamente sguarniti quel giorno? La verità è che le segnalazioni ci sono state, sono state debitamente raccolte dai livelli più bassi dell’intelligence e dell’esercito, e regolarmente trasmesse ai vertici, i quali le hanno invariabilmente – e inspiegabilmente – scartate. Nel novembre 2023, il New York Times ha rivelato che, almeno un anno prima dell’attacco, l’intelligence israeliana era già in possesso di un documento, il cui nome in codice era “Mura di Gerico”, il quale descriveva in ogni dettaglio l’azione che Hamas avrebbe compiuto il 7 ottobre. Nelle sue linee generali questo piano era noto fin dal 2014. Ma i vertici militari e dell’intelligence israeliana non hanno mai approntato alcun piano per contrastare una simile eventualità. Naturalmente, ogni indagine su cosa sia realmente accaduto quel giorno è stata sospesa, rimandata alla fine della guerra. Anche per questo né il governo né i vertici degli apparati militari e di sicurezza hanno interesse a porre fine al conflitto».
Qual è il peccato originale di ciò a cui stiamo assistendo ora?
«Il peccato originale è quello di un popolo che è stato progressivamente espropriato della propria terra. Quello israelo-palestinese è essenzialmente un conflitto per la terra. Viene solitamente ricordata la “Nakba”, la catastrofe del 1948, allorché 750.000 palestinesi furono cacciati dai loro villaggi e appezzamenti, in coincidenza con la nascita dello Stato di Israele. Ma, come osservano i palestinesi, la Nakba è un processo continuo, che ebbe inizio ben prima del ’48, continuò con l’occupazione del ’67, con l’incessante costruzione degli insediamenti (una costruzione addirittura accelerata dopo gli accordi di Oslo del ’93 e l’inizio del cosiddetto processo di pace), e prosegue tuttora, un processo di lenta e graduale pulizia etnica ai danni del popolo palestinese».
Lei sconfessa la narrazione degli stupri e delle violenze indiscriminati e metodici ai danni della popolazione israeliana. Da giornalista, come reagisce a quella narrazione?
«Siamo stati sottoposti a un bombardamento mediatico incentrato su storie da film dell’orrore – non solo stupri, ma mutilazioni, torture e atrocità inimmaginabili – senza alcun tentativo di verificare le fonti, l’attendibilità di queste notizie. Esse ci sono state somministrate come indiscutibilmente vere, inoppugnabili. A un’analisi appena più approfondita, tali episodi sono stati smentiti, si sono rivelati inattendibili. L’ultimo in ordine di tempo ad aver fatto questo lavoro è il Times di Londra. Eppure queste storie tanto atroci quanto infondate continuano a circolare sui media. A posteriori, sembra evidente che si sia trattato di una campagna propagandistica, promossa e incoraggiata dal governo Netanyahu, per giustificare l’immane distruzione prodotta dal durissimo intervento militare israeliano a Gaza. Ma quello che colpisce è lo scarso livello di certa stampa occidentale, che ha recepito questa campagna senza il benché minimo tentativo di verificarne le fonti. Ciò non significa, ovviamente, che Hamas non abbia commesso violenze».
Il leggendario corrispondente dell’Independent dal Medio Oriente, Robert Fisk, sosteneva che, prima o poi, gli USA avrebbero tolto il loro appoggio incondizionato a Israele. Le scaramucce tra Netanyahu e Biden a me sembrano un litigio fra un papà senescente e un figliolo arrogante. A lei che impressione danno?
«La senescenza di Biden incarna la debolezza della declinante superpotenza americana, che si fa dettare la linea politica da quello che dovrebbe essere uno Stato satellite, invece di imporgli la propria. Il sostegno americano all’azione militare del governo Netanyahu è stato illimitato ma, soprattutto negli ultimi mesi, sono emersi anche dissidi reali, in particolare su come gestire Gaza dopo la fine del conflitto e su quando porre fine alle operazioni belliche. In tutti questi casi, Biden ha sempre finito per cedere, non ha mai esercitato pressioni concrete su Netanyahu, sebbene abbia i mezzi per farlo. L’influenza della lobby israeliana negli USA, dalla quale egli dipende per la campagna presidenziale, si è rivelata un fattore decisivo. Per gli Stati Uniti, tuttavia, il danno d’immagine nel mondo arabo, e più in generale nel cosiddetto Sud globale, è incalcolabile. Al di fuori dell’Occidente, Washington è vista perlopiù come complice dello sterminio condotto da Israele a Gaza. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre trattato Biden con arroganza, anche prima della guerra. Egli punta a prolungare il conflitto sapendo che, se dovesse finire, per lui arriverebbe la resa dei conti in Israele, dove ha perso consensi e deve rispondere, insieme ai vertici dell’esercito e dell’intelligence, del disastro del 7 ottobre di fronte all’opinione pubblica. Perciò forza la mano alla Casa Bianca, sapendo di poter contare su alleati potenti a Washington. Spera di guadagnare tempo e confida nella vittoria di Trump in novembre».
So che c’è una spaccatura forte tra gli osservatori che optano la soluzione dei due stati separati e quelli convinti che solo uno stato unico con partecipazione democratica di entrambe le parti sia possibile. Lei come la vede?
«La soluzione dei due Stati è stata resa di fatto irrealizzabile dalla continua espansione degli insediamenti israeliani. Ci sono almeno 700.000 coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Una loro evacuazione è impensabile. In Israele la volontà politica per compiere un’operazione di simili proporzioni non si materializzerebbe mai. Uno Stato bi-nazionale con pari diritti per ebrei e palestinesi è sulla carta maggiormente attuabile. In fondo, in Sudafrica si è arrivati a una soluzione di questo tipo, pur con tutti gli enormi problemi che ancora affliggono quel paese. Ma un simile scenario richiederebbe tempo e questa drammatica guerra sembra indicare che proprio il tempo a disposizione sia tragicamente finito. Non si vede alcuna soluzione praticabile all’orizzonte. Né il governo Netanyahu né l’amministrazione Biden hanno un piano realistico per la fase postbellica. Soprattutto, non c’è nessun piano in grado di dare una qualche prospettiva ai palestinesi. Il rischio è che Gaza scivoli in una sorta di conflitto permanente, seppure a intensità ridotta, in un contesto umanitario catastrofico. Con il protrarsi delle operazioni belliche, inoltre, continua a crescere il pericolo di un allargamento della guerra, in particolare al Libano, cosa che sprofonderebbe la regione in una catastrofe di proporzioni ancora più spaventose».