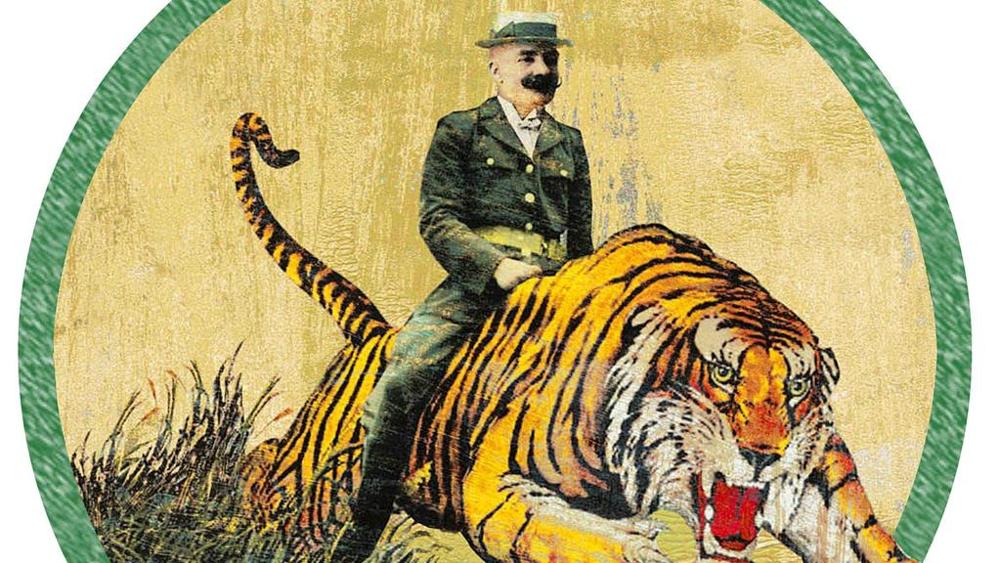di Rock Reynolds
I sapori, i profumi, i suoni e le tinte mediorientali sono una costante, l’elemento letterario che non ha bisogno di mediazione poetica per assumere quel lirismo che da sempre contraddistingue un angolo di mondo agli occhi di noi europei, in particolare di noi italiani, tutto sommato alquanto vicino per geografia e assonanza storicoculturale. Si affaccia sul Mediterraneo, il mare nostrum tanto caro agli antichi romani, e ancor oggi capace di fascinazioni travolgenti.
La moglie (Gabriele Capelli Editore, traduzione di Carlotta Bernardoni-Jaquinta, pagg 157, euro 18), della svizzera e belga Anne-Sophie Subilia, è la storia di Piper, la giovane consorte di un giovane delegato della Croce Rossa che per un anno si trasferisce in Palestina, nei pressi di Gaza, al seguito del marito, un funzionario destinato a una brillante carriera. L’anno è il 1974 e la guerra dello Yom Kippur (nota pure come guerra israelo-araba) è ancora un fatto recente. La guerra ha visto schierati, da una parte, Egitto e Siria e, dall’altra, Israele, ed è stata anche un tentativo di riequilibrare in qualche modo il pesante smacco subito dagli egiziani nel 1967, con la guerra dei sei giorni. Israele si è trovato sull’orlo di un baratro militare per la prima volta nella sua giovane storia e la conclusioni senza vincitori né vinti non ha fatto altro che rafforzare nel popolo israeliano la convinzione di dover fare da sé, in barba a ogni trattato internazionale e a ogni dichiarazione dell’inviolabilità universale dei diritti umani. La crisi nella vicina Cipro e, soprattutto, la complicatissima situazione del prezzo del petrolio che per mesi terrà in scacco l’Occidente acuiscono il senso di isolamento e di sospensione della normalità internazionale in una terra che non avrà più pace.
La vita, per i giovani coniugi, dapprima pare carica delle promesse che un incarico prestigioso come quello di Vivian, il marito, si porta inevitabilmente appresso, per giunta in un ambiente carico di suggestioni esotiche, che trasuda storia da ogni poro. Vivian, tra le altre cose, deve vegliare sul rispetto dei diritti umani in quella terra già martoriata. Siamo ancora lontani da certe nefandezze e da certe distorsioni che, purtroppo, hanno finito per rappresentare una routine quotidiana su cui nemmeno la stampa internazionale, per convenienza o assuefazione, punta più i fari, se non in occasione di stragi o eventi epocali. Ma per Piper, nata in Inghilterra nel dopoguerra e avvezza a un clima culturale esuberante, quello della Swingin’ London di fine anni Sessanta (con la sua dose di lotte quotidiane e il suo percorso senza grandi ostacoli verso l’emancipazione del ruolo della donna nella società), non c’è granché da fare, se non passeggiare sulla spiaggia e attendere il ritorno a casa del marito, spesso assente per giorni mentre è in missione nell’interno del paese. Il weekend è sempre il momento della socializzazione, inevitabilmente al Beach Club, il circolo privato sul mare in cui si raduna la sparuta congregazione degli expat, gli occidentali un po’ viziati e un po’ debosciati che affogano nell’alcol stanchezza e stress accumulati durante la settimana. È una routine rassicurante, anche perché di grossi inconvenienti la coppia non ne incontra. Pazienza se il consumo d’alcol talvolta si fa smodato. Nessuno giudica nessuno. Eppure, manca qualcosa. Manca la rassicurante, vecchia Europa. Manca lo humour “buontempone” londinese del fratello. Manca la normalità di relazioni sociali non obbligate, in un ambiente libero in cui non siano il privilegio e la provenienza geografica a dettare l’intensità o la vacuità dei rapporti. Forse, manca pure un’autentica reciprocità coniugale in grado di far sentire moglie e marito sullo stesso piano e di trasmettere alla donna il necessario senso di completezza: attendere il marito e fargli da ombra silente non è certo il massimo per una donna occidentale, dinamica, moderna, di buona famiglia e, persino nell’ormai lontano 1974, nemmeno l’amore basta. Eppure, Vivian non è un marito privo di attenzioni: si rende conto che le certezze che finora hanno caratterizzato il suo matrimonio faticano a restare tali. Ogni tanto chiede alla moglie di accompagnarlo in giro per il paese, condividendo con lei le bellezze mozzafiato che la storia, la geografia e l’umanità del luogo regalano a piene mani. Si tratta di pause salutari dalla monotonia di quell’esistenza sospesa – entrambi i coniugi sanno benissimo che la Palestina è una tappa transitoria di un viaggio che li porterà sicuramente in molti altri angoli tormentati del globo – ma pur sempre di semplici deviazioni da un trantran devastante e da una tensione coniugale crescente.
Una delle migliori frecce all’arco di Anne-Sophie Subilia è la scelta di trasformare la questione palestinese in un sostanziale rumore di fondo, in un fruscio immancabile nelle retrovie: i palestinesi ne parlano poco, gli israeliani non ne parlano proprio. Solo nella seconda parte del romanzo, il clima politico si prende leggermente di più la scena. Ma resta sullo sfondo. Il che non significa che l’autrice non semini qualche sassolino, lasciando intendere come la pensi. Tocca al lettore unire i puntini. La moglie è un romanzo psicologico, la storia di un amore profondo che rischia di scricchiolare sotto i colpi impalpabili di un ambiente non certo ostile ma difficile da interpretare, dove la cultura araba e quella ebraica si fondono senza mai essere una cosa sola, anche perché a entrambe strizza inevitabilmente l’occhiolino il fagocitante capitalismo sempre più globalizzato di un Occidente che, piaccia o non piaccia, piace a molti, se non a tutti.
I riferimenti alle tradizioni e peculiarità locali arricchiscono una narrazione che, di primo acchito, potrebbe sembrare arida, distaccata. È una scelta stilistica voluta e, per come l’ho colta io, vincente. Sono le parole e i gesti dei protagonisti ad arricchirla. Sono le piccole relazioni umane che nascono in loco, soprattutto quella con l’anziano e malridotto Hadj, un giardiniere arabo che riesce a trasformare il cortile inospitale della casa assegnata alla coppia in un giardino, facendo spuntare con amore fiori e piante. La sua pudicizia fa il paio con la curiosità esuberante di Piper e strappa qualche sorriso.
C’è, purtroppo, meno da sorridere quando si capisce a quali piccole umiliazioni il popolo palestinese sia sottoposto quotidianamente, come ogni volta che i pendolari devono attraversare il famigerato valico di Erez per recarsi al lavoro in Israele, tutto in nome della sicurezza dei vicini di religione ebraica. E che dire delle promesse inevase riguardo alle fasce di “protezione” dei territori occupati? Dov’è la giustizia per chi si è visto strappare casa e terra? Qualcuno, nella realtà così come in questo romanzo, addita il peccato originale ai colonizzatori inglesi, che per primi avrebbero lasciato fare a Israele di testa propria. È un mondo complesso, ma, se la storia la scrivono soltanto i vincitori, anche chi non si sottrae all’idea di una sconfitta perenne e lotta da par suo può graffiare le pietre del deserto per indicare un’altra verità.