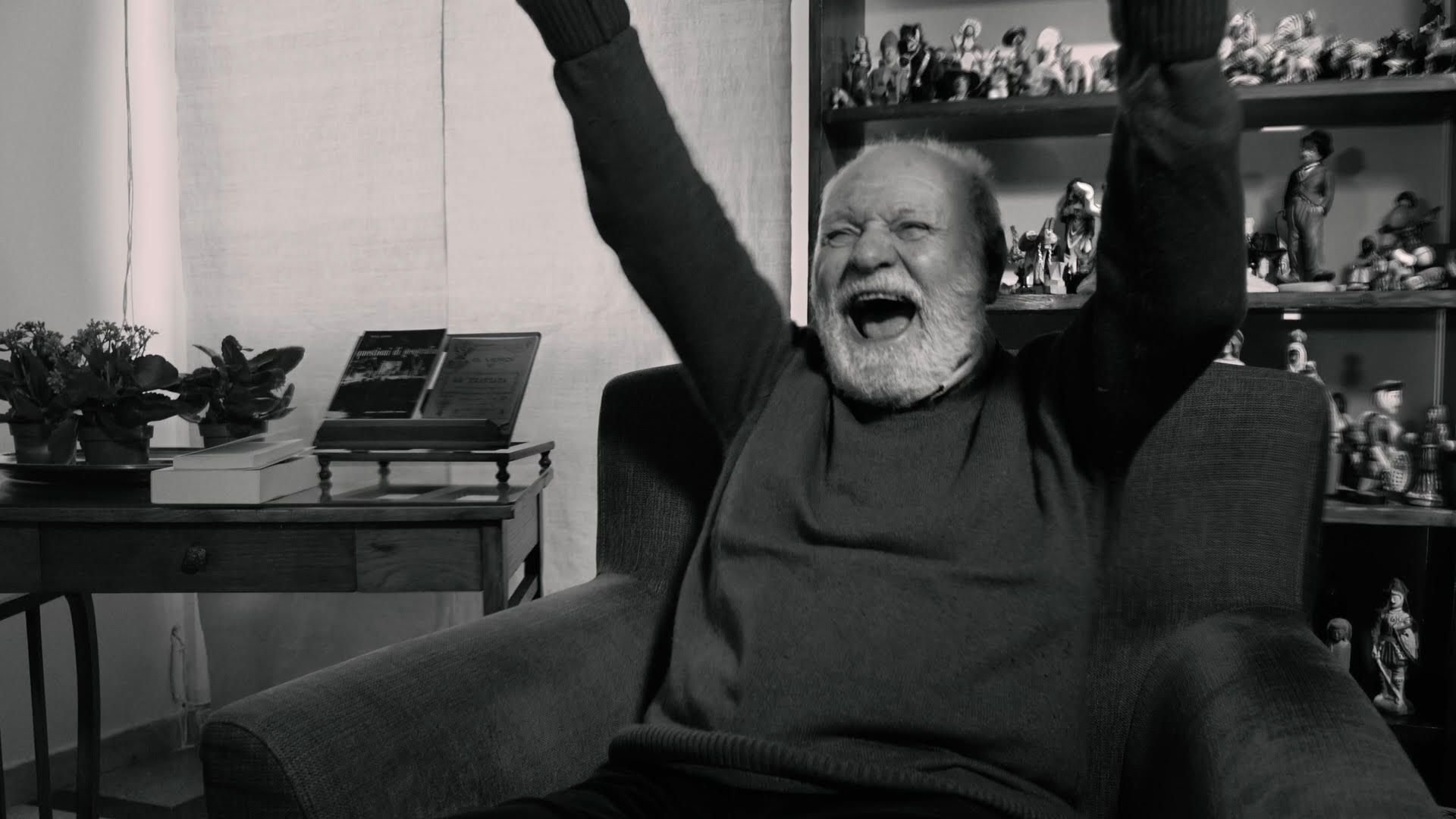di Marco Maiocco
Milano è una città di pianura, per parafrasare Gianni Celati. In una città di pianura tutto appare a portata di mano, nel senso che non sembrano esserci soglie reali, ostacoli naturali, paesaggistici, a determinare e segnare visibilmente confini ambientali, sociali e culturali. Una città di pianura, anche una metropoli come Milano, ricca delle sue possibilità e molteplicità, dei suoi spazi e delle sue distanze, la si può facilmente percorrere tutta in bicicletta, da una parte all’altra, da nord a sud, da est a ovest. A Milano, citando Cesare Zavattini, che così diceva della sua Bologna (ce lo ricorda Paolo Nori in un divertente libro di non molto tempo fa), le biciclette sono (davvero) come i cani, o così sarebbe bello che fosse o tornasse ad essere. Anche se un Coppi e un Bartali, il primo figlio della terragna e smeralda (in questa stagione) campagna alessandrina, il secondo delle rotonde e dal carattere arcigno colline toscane, orbitanti attorno a Firenze, non avrebbero probabilmente mai potuto nascervi.
Milano, insomma, la puoi “viaggiare”, anche attraverso lunghe camminate, strato dopo strato, o forse è meglio dire sezione dopo sezione, spicchio dopo spicchio, vista la sua ossatura a circonferenze concentriche, a protezione di un unico centro. Ma in una città di pianura, paradossalmente, l’orizzonte, per esempio (appunto) quello della verde e fuligginosa campagna padana, sulla quale Milano è “spalmata”, non è illimitato, a perdita d’occhio, nel senso che non vi è mai un punto privilegiato d’osservazione, una collinetta, un poggio, un promontorio, o una “roccaforte”, a partire dalla quale discernere, distinguere, comprendere, mappare, la conformazione di un luogo, il suo ordine o il suo disordine, la sua composizione, il reticolo e la distribuzione dei suoi “allacciamenti”.
Un punto a partire dal quale meglio posizionarsi, o meglio realizzare la propria disposizione rispetto allo spazio circostante. Anzi, (di nuovo) paradossalmente, c’è sempre un edificio, un grattacielo, un qualche torracchione di bianciardiana memoria, un qualche interminabile isolato, “acquartieramento”, ad ostruire lo sguardo, a fermarne le ambizioni esplorative, cognitive e immaginifiche.
In questo senso Milano è come fosse eternamente unidimensionale o bidimensionale (può mancare la prospettiva, nonostante tutto lo spazio, la fondamentale possibilità di uno sguardo d’insieme, tanto che a volte sembra quasi di ritrovarsi appiattiti, schiacciati, in un trecentesco quadro di Ambrogio Lorenzetti), e al contempo multidimensionale, perché spesso tutto è contemporaneamente e simultaneamente nella stratificazione all’interno del medesimo spazio, sia in senso “armonico”, sincronico o storico – verticale -, sia in senso “melodico”, diacronico o “sillogicamente” temporale – orizzontale -.
Per questo motivo Milano è costantemente sorprendente, spiazzante, potremmo dire spaesante, perché tutto sembra non cambiare mai (da qui la noia del vivere in pianura, e il bisogno di “ingaggiarsi” sempre, per non farsi travolgere dalla “nausea”), quando invece tutto cambia continuamente e soprattutto repentinamente: a Milano giri l’angolo ed improvvisamente ti ritrovi immerso in un’altra “zona”, in tutt’altre dinamiche e atmosfere.
Milano, quindi, come centro del “disorientamento”, a dispetto della sua rigorosa, e tutto sommato ordinata, anche se “irregolare”, conformazione romana (i romani non l’hanno fondata, ma conquistata agli Insubri verso la fine del III secolo A.C. – ed ecco perché a Milano in realtà non ci si perde mai realmente, se non solo allegoricamente: Milano non è certo costruita da un labirintico dedalo di strade, da un intricato centro storico, pur non essendo costituita da “piazzeforti imperiali parigine”); e a dispetto, dicevamo, della sua “originaria” funzione, quella che per lo meno le hanno affidato i romani, ovverosia d’essere punto di riferimento e di mediazione (Mediolanum, “nel mezzo della pianura”, lo sappiamo, è il suo antico nome latino), nel bel mezzo di un’indefinita e sfuggente pianura, che all’epoca di Giulio Cesare (per esempio) dev’essere sembrata sconfinata e del tutto incontrollabile, e che nel Medio Evo, al tempo in cui le strade romane diventano insicure, è stata certo ammantata dalla presenza di oscure e vertiginose entità soprannaturali, come se Conan Doyle vi avesse già intravisto o delineato la figura diabolica del “mastino dei Baskerville”. Ma in realtà non sappiamo (colpa nostra, non ne siamo sufficientemente edotti) che clima “imperversasse” nella valle del Po’ nel I secolo A.C. o tra il V e (diciamo) il XII secolo D.C.: quella della “nebulosa brughiera” è solo una nostra suggestione.
Ma se ci pensiamo bene (probabilmente senza fare nemmeno troppa fatica), e sempre da osservatori viaggianti, Milano può davvero essere una delle città simbolo (forse esempio unico in Italia – ? -) del passaggio in Europa dall’arte romanica a quella gotica, definitivamente nordica, germanica, e soprattutto oscura, misteriosa, labirintica, immersa nel mondo magico e “meraviglioso” dell’età di mezzo della nostra era.
L’imponente e spettacolare Duomo tardo gotico con le sue guglie, le sue tetre e fantastiche miniature medioevali (i doccioni o gargoyles), le sue arzigogolate “vie di fuga”, le sue “infiorettature” già barocche in qualche modo, sembra sempre lì a ricordarcelo. Una struttura certo differente dalla (per esempio) più essenziale e precedente Basilica di Sant’Ambrogio (rifugio per i perseguitati cristiani, prima, e simbolo dell’affermata e potente cristianità, poi), edificata (senz’altro) in epoca tardo romana sul finire del IV secolo D.C., ma poi sostanzialmente ricostruita nel X secolo D.C., secondo i dettami dell’allora imperante e più asciutto, geometrico, con i suoi squadrati mattoni a vista e le sue “antiche” volte, stile romanico. Decimo secolo, per altro, ci piace ricordarlo, che è proprio il momento a partire dal quale nella cosiddetta società occidentale si creano i presupposti e le nuove condizioni, anche per la progressiva diminuzione delle irruenti “migrazioni barbariche” (i barbari che si sedentarizzano, “finalmente” anche in Europa centro settentrionale e orientale), per un nuovo tipo di comunità urbana, più libera, indipendente (in opposizione alla chiusa, rurale, aristocratica e verticistica società feudale), più sicura, forse più giusta, fondata sul nascente prestigio di una borghesia in nuce e di una nuova classe emergente, quella dei mercanti: è l’inizio della città, come oggi la conosciamo, di un nuovo, non più antico (come per esempio l’idea di assemblea permanente di tutti i cittadini aventi diritti politici, che permeava la polis ateniese, secoli prima di Cristo), concetto di agglomerato e organizzazione urbana, che informerà (purtroppo o per fortuna, perché in fondo protocapitalista) la nostra cultura nei secoli avvenire, fino ai giorni nostri, fino alla Milano dei giorni nostri.
Milano, insomma, tornando alla metropoli meneghina, o è città antica, con le sue eleganti porte romane (che stavamo lasciando da parte) e la meravigliosa teoria delle sue chiese (romane, romaniche, o rinascimentali, ma sempre figlie di quel linguaggio estetico), appartenenti all’arcidiocesi più estesa ed importante, o è “longobarda”, medioevale – misteriosa quindi -, o conseguentemente fortificata e sforzesca; e poi risorgimentale (una città “da cinque giornate”, con buona pace del generale Radetski), e ancora liberty, razionale, partigiana e “senza tregua”, come avrebbe detto Giovanni Pesce, moderna e postmoderna (una città del ‘900 insomma), ma non certo (potremmo dire) luminosamente rinascimentale, o classico cinquecentesca, come la Roma di Papa Giulio II. Quindi nessuna sorpresa se ogni tanto, viaggiando al suo interno, è la sensazione di addentrarsi in una dantesca “selva oscura” a prendere il sopravvento. Ma, per carità, stiamo solo giocando, Milano non è certo solo un “oscuro” insediamento, è davvero molto altro, pensiamo (per esempio) ai suoi parchi. Probabilmente è solo il suo forte carattere urbano e industriale ad averla resa una specie di soffocante “giungla”.
Ma lo spazio (si sa), riportando l’attenzione al movimento attraverso le forme spaziali e le conformazioni territoriali, al tempo, che è casa, e che non può esistere senza le distanze, e al complesso reticolo delle relazioni umane, è multidimensionale per definizione, non euclideo (per l’appunto), e al suo interno le “particelle elementari” si muovono spesso in modo imprevedibile, e come su pareti sovrapposte di fogli arrotolati (forse le ulteriori dimensioni o mondi (?), con le quali ci interfacciamo). Ed ecco che allora bisogna con ancora più attenzione, acume e scrupolo, leggere e interpretare, come diceva l’antropologo Clifford Geertz, i segnali visibili e invisibili della cultura che compone una città come Milano, o meglio delle molte culture o mondi che oggi (più di ieri) la intessono e impreziosiscono, spesso confinate in zone periferiche della città, che hanno il merito di stare diventando poco alla volta, zone “centrali”, nel senso di vive, autentiche, essenziali, rispetto a un centro svuotato dall’interno di contenuti etici, umani e culturali, forse simbolo di quella carestia morale, così definita di recente dallo storico Giovanni De Luna, che attanaglia, sgretolandolo, il nostro tempo.
Anche a partire da questa visione, da questo punto di osservazione, da questa sensibilità, in ultimo da questo spirito, nasce e si sviluppa un progetto, una “rassegna” interculturale (non un festival delle culture o dei popoli, ma la messa in opera delle culture e delle capacità, competenze, creatività, risorse, che oggi vivono e abitano Milano nella quotidianità), o meglio sarebbe dire un processo, vista la quantità di realtà coinvolte in una paritaria, sinergica e costruttiva collaborazione (Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, Scuola Primaria Narcisi, Radio Popolare, Le Radici e le Ali, Dencity, Rete scuole senza permesso, Rete 2G, Università Bicocca, Giambellitaly, Teatro Utile, Samarcanda), come il Jambellico del Mondo.
In programma venerdì 20 e sabato 21 giugno nel quartiere Giambellino-Lorenteggio, il Jambellico del Mondo vuole offrire un’occasione per fare, riflettere e parlare di intercultura attraverso le visioni delle ‘seconde generazioni’, e con gli abitanti, le reti di attivisti, volontari, associazioni, cooperative, soggetti che riconoscono nella pluralità una ricchezza per il divenire.
Jambellico si presenta come un cantiere di creatività interculturale che, a partire dalle esperienze delle ‘seconde generazioni’, intende restituire alla città il valore dell’intercultura e delle sue pratiche. Per questo viene proposto non come un festival-vetrina, ma (in primis) come un evento di sintesi e aggregazione dei percorsi interculturali milanesi; e (in seconda battuta) come una fucina esemplare, in cui possano compiersi in tempo reale alcune esperienze interculturali legate al territorio, alle arti e alla creatività.
Pensato come evento culturale cittadino, Jambellico è promosso dal progetto Dencity, un meritorio e articolato piano triennale, sostenuto dalla Fondazione Cariplo, rivolto alla rigenerazione territoriale, alla coesione sociale e allo sviluppo economico delle comunità locali, attraverso la valorizzazione dell’intercultura e delle capacità e competenze realmente presenti sul territorio, e si scandisce annualmente per tre anni (Marzo 2014; Giugno 2014; Giugno 2015), in un’ottica di progressivo ampliamento della adesione cittadina (enti, gruppi, progetti, popolazione locale ed extra-locale, city-users, istituzioni, università).
Dopo il successo dell’edizione 0 di Marzo 2014, la prospettiva, dicono gli organizzatori, è quella di consolidare Jambellico del Mondo come un appuntamento annuale cittadino, autonomo e capace di replicarsi nel tempo, oltre la fine del triennio sostenuto da Dencity, attraverso “l’estensione e il consolidamento di un format culturale, l’aggregazione di un piccolo gruppo promotore/cabina di regia di respiro cittadino, l’intercettazione e costruzione di una rete di esperienze significative locali e cittadine, la concezione di un primo dispositivo di replicabilità e sostenibilità economica”.
Jambellico del Mondo cerca di rispondere dunque all’esigenza che Milano riconosca la Milano del mondo, e lo fa in un luogo emblematico della città, dove la convivenza interculturale è relazione quotidiana che vive: la periferia urbana del quartiere Giambellino-Lorenteggio. Un quartiere, che, grazie agli interventi di lungo termine del progetto Dencity per valorizzare e favorire l‘intercultura, l’autodeterminazione e l’emancipazione del territorio e delle sue comunità, oggi è probabilmente pronto ad accogliere un’idea o meglio un ideale come il Jambellico del Mondo, partecipandovi attivamente, e consentendone il radicamento e l’integrazione nel tessuto cittadino.
Un quartiere, il Giambellino-Lorenteggio, nel quale la presenza di migranti è pari al doppio della media cittadina, e dove l’intercultura e le seconde generazioni sono, devono essere, una risorsa per trasformare il quotidiano. Nel Giambellino-Lorenteggio, a lungo isolato dall’azione istituzionale, si sono sviluppate e radicate competenze di coesione sociale e un fervido tessuto associativo. Diverse le questioni irrisolte – scuole in difficoltà, abbandono degli immobili pubblici, difficile dialogo tra generazioni e provenienze – che riconoscono nel protagonismo dei soggetti locali una possibile risposta. Il quartiere prova a diventare così un territorio di sperimentazione, dove la comunità locale è capace di autopromuoversi, attraverso iniziative rivolte alla città.
“Perchè Milano è un laboratorio culturale a cielo aperto. Un crocevia del mondo, fra molti. Il caravanserraglio, in cui ogni giorno scambiamo parole con sguardi, sguardi con sogni, sogni con saperi, saperi con mestieri, affinchè tutto ciò giunga lontano da noi e lì possa trasformarsi ancora. Qui non raccontiamo solo da dove veniamo, ma anche dove siamo diretti. Qui non raccontiamo solo cosa portiamo, ma anche cosa stiamo cercando. Non siamo di passaggio, noi oggi abitiamo Milano viaggiando fra le sue culture”.
E perchè “l’intercultura è una risorsa collettiva, un potenziale che rigenera la città a partire dai più giovani e dalle loro aspirazioni, dalle esperienze che stanno a cavallo fra culture e qui si incontrano e dialogano, si contaminano, reinventando ogni giorno Milano e modi possibili per abitarla”.
Nel ricco e nutrito [url”programma del Jambellico”]http://www.dencity.info/jambellico-summer-edition/[/url], è prevista anche una densa proposta musicale, con un’attenzione rivolta a musiche (potremmo dire) della diaspora o delle diaspore, o meglio ancora delle migrazioni, coatte o spontanee che siano state, ma sempre produttive di ulteriore ricchezza, confronto, nuova conoscenza: dalla musica rom e zingara al klezmer e più in generale alla musica ebraica in tutte le sue sfaccettature, a musiche afroamericane, come il reggae, il tango, per il quale è previsto un laboratorio di ballo, e perfino la capoeira, la nota lotta figurata acrobatica brasiliana, che è “danza” sì, ma su precisi pattern ritmici, scanditi da due strumenti afroamericani come il cordofono berimbao e il pandeiro, il caratteristico piccolo tamburo a cornice, corredato da tintinnanti sonagli.
E proprio sulla musica “israelitica” vogliamo soffermare la nostra attenzione, segnalando la preziosa partecipazione del NefEsh Trio, “agguerrita” formazione milanese, capace di muoversi abilmente con sapienza, brio e freschezza tra il repertorio sefardita e quello askenazita (ma non solo). Perché in ogni brano dei NefEsh (Daniele Parziani, Violino; Manuel Buda, Chitarra; Davide Tedesco, Contrabbasso) è impossibile non sentire anche altro: jazz, musica balcanica, tango, melodie arabe e altre forme di musica popolare, e senza mai trascurare la ricerca di un suono personale, intriso di una profonda ispirazione e di un’autentica, “viscerale”, anima (la parola nephesh pare sia appunto la traslitterazione di un’antica radice ebraica, che significa “anima” – intesa come “principio vitale” -, letteralmente “il soffio del respiro”).
D’altronde tra il klezmer e (per esempio) il jazz esiste da sempre un rapporto molto stretto. Il jazz, infatti, musica afroamericana per eccellenza sì (per i parametri che lo contraddistinguono: il suono, il ritmo, l’obliqua intonazione, il concetto di swing, su tutti), ma certo non solo neroamericana, custodisce una sorta di debito segreto nei confronti della musica klezmer (tanti i musicisti delle origini del jazz e non solo, che provenivano e provengono dalla cultura ebraica); e (per altro verso) il klezmer (in yiddish, la lingua ebraica dell’est Europa, della diaspora askenazita, significa indicativamente qualcosa come l’espressione “strumenti di canto”) è stato abbondantemente rivitalizzato dal suo rinnovato articolarsi all’interno dell’intera vicenda delle note afroamericane, oltre che dal pirotecnico revival, americano soprattutto, della seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso (pensiamo solo ad uno storico gruppo come i Klezmatics, per citare solo la realtà più nota e blasonata).
Il NefEsh Trio nasce nel giugno del 2006 dall’incontro di tre virtuosi, usciti dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, con alle spalle una non comune esperienza in diversi generi musicali, quali il tango, il jazz, il rock, la musica popolare, oltre alle cosiddette conoscenze accademiche. Anche grazie alla loro brillante e coinvolgente musica, possiamo fortunatamente continuare a riscoprire quell’antico mondo ebraico, che tanto ha a che vedere anche con la nostra storia e formazione culturale (quella di noi “cristiani”); quella cultura del “libro” (quello sacro, per eccellenza) e della “parola” continuamente tramandata, o (per esempio) dello shtetl (l’antico villaggio ebraico dell’est Europa) e dei canti sinagogali intrecciati a melodie zingare, o della figura del violinista errante, così cara a Marc Shagall e alle sue colorate “visioni”; o ancora quella singolare modalità yiddish nel portare la melodia, nel concepire il “canto”, con quella spesso sospesa esposizione tematica, distribuire, sgranare irregolari accenti e spigolose infiorettature, che nelle intenzioni dei nazisti avrebbe dovuto essere completamente annientata, obiettivo in parte (per fortuna solo in parte) tragicamente realizzato dal terrificante e programmato sterminio di massa nazionalsocialista.
Nel suo allegorico e risonante, come gli irriverenti e scapigliati armonici di una zampogna o i “magici” sonagli di un carretto siciliano, “Conversazione in Sicilia” Elio Vittorini, forse nel momento più cupo della nostra storia (la metà degli anni ’30 del ‘900 con il regime fascista al suo apice, il “soccorso” all’azione franchista, la guerra coloniale d’Etiopia, le leggi razziali, l’alleanza con Hitler e l’entrata nella seconda guerra mondiale), fa pronunciare al Grande Lombardo, un viaggiatore che il protagonista incontra sul treno di ritorno verso la Sicilia e l’intensa conversazione con la madre (una sorta di arcaica figura di sintesi), e così soprannominato dall’autore, che probabilmente aveva in mente il dantesco e nobile (d’animo e di censo) abitante del Paradiso Bartolomeo della Scala, le seguenti parole: “- Credo che l’uomo sia maturo per altro, – disse. – Non soltanto per non rubare, non uccidere, eccetera, e per essere buon cittadino… Credo sia maturo per altro, per nuovi, per altri doveri. È questo che si sente, io credo, la mancanza di altri doveri, altre cose, da compiere… Cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo”. Chissà che il Jambellico del Mondo non sia una di queste cose.